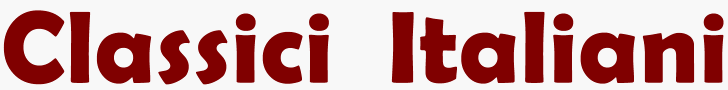Maria Messina.
La casa nel vicolo.
Capitolo 2
1921.
| Note Diritti d’Autore: no Edizione di riferimento: Maria Messina, La casa nel vicolo, Sellerio Editore, Palermo, 1982 |
|
Capitolo 2.
Avendo finito i lavori di scuola, Alessio metteva libri e quaderni a piramide sul piccolo tavolino che stava a piedi del letto di Nicolina. Canterellava.
— «Io ti seguìa com’iride di pace…».
S’interruppe di botto.
— Zia Nicoli’! Sei mai andata a teatro? – domandò chiudendo il cassetto.
— Mai.
Riprese a canticchiare, ma tornò a interrompersi.
— Sai, zia Nicoli’, un compagno mi ha invitato a sentire la Manon in palco, una vera fortuna…
Nicolina posò il lavoro e guardò fuori della finestra tonda, sospirando.
— Allora – disse, – bisogna domandare il permesso.
— È perfettamente inutile – esclamò Alessio.
— Chi sa… A coglierlo in un momento buono.
— È inutile – ripeté il fanciullo con amarezza. – E se pure lo concedesse! Dopo che tira tira, dopo che trepidazioni potrei dire al mio compagno: vengo con te. E poi… Tu e la mamma che vegliate per me, lui che aspetta seccato. No, no… Perché infine tu credi veramente che il piacere consista nell’ingollarsi un divertimento? Niente affatto. Consiste nel gustarlo con animo sereno, spensieratamente… Perciò – aggiunse dopo una pausa, con tono più calmo, – perciò ho risposto al mio compagno che non andrò neppure questa volta.
— E forse è meglio così – fece Nicolina rasserenata.
— Non è meglio – replicò Alessio di nuovo eccitato. – Almeno per me non è meglio. Io non posso fare la vita che fai tu, che fa la mamma o Carmelina… Siete tutte donne. Un lavoruccio tra le mani, o sentir la messa la domenica, basta a svagarvi. Io penso a tante cose… Desidero tante cose… Certe volte mi gira la testa, così forte mi entusiasmo… No, è inutile. Tu non mi capirai mai!
— Non bisogna lagnarsi… specialmente del padre che ci ha dato la vita!
— Che c’entra! Io non mi lagno. Chi ha parlato di lui, adesso? Gli manco forse di rispetto? Che c’entra lui? È forse colpa mia se non mi contento? Ma tu non puoi capirmi. Tu e la mamma vi siete adattate, ora, come la lumaca che ha la forma del suo guscio…
— Ma, Alessio! – esclamò Nicolina con tono di rimprovero. – Tu sei ancora un bambino e perché hai imparato un po’ di «latinorum» ti credi di poter giudicare quelli più grandi di te! Pensa a crescere, senza troppe fantasticaggini.
Le pareva che, riprenderlo, fosse un dovere da parte sua.
— Sicuro! – fece Alessio sforzandosi a sorridere perché si sentiva salire le lacrime agli occhi. – Sicuro, crescere per fare anch’io, un bel giorno, l’amministratore di un signore qualunque.
— E non è forse una professione onorata?
— Chi dice che non sia onorata? Anzi. «Di quella pira l’orrendo foco…».
— E poi – l’interruppe Nicolina, – non è vero che farai l’amministratore. Che ne sai, tu, delle intenzioni di tuo padre?
— Le so. Le conosco. È per questo che mi dispero. Ingegnere! «Alessio Gaspare Carmine, perito ingegnere». Come suona bene! Oppure: «Carmine Alessio, ingegnere». Oh, io penso ad altro. Se sapessi quel che soffro quando penso che «dovrò» seguire quel maledetto corso…
— Ma calmati, adesso. Perché ti agiti così? Il tempo dell’Università è così lontano! Siamo forse noi i padroni del tempo?…
E Nicolina chinò il capo, non osando più rimproverare il nipotino.
Certo, i maschietti non somigliano alle femminette! Cominciano presto a batter le ali! Quel povero ragazzo era proprio come un uccello che vuol provare il volo dentro una gabbia di ferro. Chi sa che pensieri passavano per la sua testolina! Ma chi poteva seguirlo nelle sue fantasticaggini? I suoi occhi timidi e dolci come quelli d’un piccolo camoscio guardavano già così lontano dove le donne non osano guardare.
Alessio era andato a vestirsi nella cameretta che era attigua a quella della zia. Canterellava sottovoce e pareva rasserenato.
Molte cose aveva taciuto. Molte cose che non ardiva domandare ad alcuno e che gli avvelenavano le pure sorgenti della vita. Nessuno era sincero in casa. Bello sarebbe stato poter dire a zia Nicolina, a cuore aperto:
«Zia, tu non devi restare qui. Cerca un rifugio, sia pure in un convento, ma non continuare a far male alla mamma e a te stessa, a tenere acceso il dissidio come una vampa che non possiamo spegnere…».
Che avrebbe risposto zia Nicolina? Egli le voleva assai bene, malgrado tutto.
Zia Nicolina l’aveva cullato tra le braccia, come la madre; l’aveva tenuto sulle ginocchia, come la madre; l’aveva calmato asciugandogli le lacrime con la mano ruvida e leggera, allorché il padre, per qualche mancanza, l’aveva battuto…
Quante volte zia Nicolina, prendendolo tra le braccia e volando su su per la scaletta, s’era rifugiata nella piccola stanza che pareva la cabina d’un vapore! e insieme, zitti zitti e vicini, erano restati a guardare fuori della finestra tonda, attraverso un velo di lacrime, il rosseggiare dei tetti e la mutevole fuga della nuvolaglia grigia e rosa nel cielo! Che ore dolci e tristi! I loro cuori si erano compresi e i pensieri si erano incontrati nel silenzio pieno di amarezza di sconforto di timore.
Sì, egli amava quella sua povera zia gracile e magra, dagli oblunghi occhi scuri che, anche nella collera, serbavano sempre una espressione di sgomento. Aveva pietà di lei. Aveva pietà della madre. Una pietà sconfinata e dolorosa che turbava la sua fresca anima di adolescente.
Era ancora un bambino quando aveva compreso che «qualche cosa», molto grave e molto brutta, rattristava come un’ombra la casa che pareva piena di pace. Aveva capito che un insanabile sordo rancore divideva tra di loro le due sorelle. Una parola colta a volo, un litigio aspro a cui aveva assistito fingendo di dormire, un’occhiata una carezza che non aveva mai più dimenticato e che gli avevano fatto orrore, avevano spiegato anche il perché della discordia. E malgrado tutto egli aveva continuato ad amare sua zia. Qualche volta si era allontanato da lei. Era rimasto nella stessa camera (lei lavorava, lui fingeva di studiare, cogli occhi fissi sulla stessa pagina) senza rivolgerle una parola, tormentato da un ricordo, da un dubbio. Ma anche in quei momenti non aveva cessato di aver pietà di lei.
— «Di quella pira…». Sai, zia Nicoli’, oggi è venuto un professore nuovo. Mi ha detto! «Toh! Alessio Carmine! Sei il figlio di don Lucio? C’era con voi una zia, Nicolina Restivo…». «C’è sempre» ho risposto io. «C’è sempre?» ha esclamato lui, meravigliato. «Non si è maritata?». È il professore Casafulli. È del tuo paese. Ti conosceva?
— Sì, mi conosceva… Perché ridi?
— Così… Se vedessi com’è buffo? Ha una pancia!
— Con chi vive?
— Oh! bella! Con la sua famiglia. Chi è che non abbia una famiglia sua quando è vecchio? Ha anche un bambino, biondo biondo che pare una pannocchia.
Nicolina corrugò la fronte. È vero, ciascuno ha la sua famiglia. Ma gli uomini sono tutti egoisti. Pensare che suo padre, buon’anima… Ebbene, era bastato non vederla più per cambiare sentimenti… Perché non si era mai fatto vivo, non aveva domandato una volta di lei?
Di che le faceva colpa sua sorella?
Essa non aveva fatto male ad alcuno. Abbandonata dalle persone che parevano le più buone, era invecchiata in quella casa come una serva fidata. A chi altri aveva fatto male, se non a se stessa? Chi aveva ingannato, se non se stessa? Era come uno il quale addenta una frutta guasta che gli fa amara la bocca.
Alessio prendeva i suoi libri.
— Io vado. Salve zia Nicolina, puella sedula…
— Vengo anch’io. Perché dici salve?
— È il saluto dei latini. Si dice anche ave.
— Non si scherza con le parole dei santi! È peccato! – ammonì Nicolina. – E tu sei troppo irrispettoso.
Scesero insieme la scala, quasi di corsa.
— Che mi fai fare! – ripeteva Nicolina ridendo e lasciandosi trascinare. – Come se avessi gli anni tuoi!
Antonietta era nella stanza in fondo alla casa, con le bambine.
— Mi benedica, mamma! – salutò Alessio, mentre Nicolina saliva sul terrazzo a stendere della biancheria. – Vado a scuola.
— Santo e benedetto, figlio mio. Hai portato l’ombrello?
— Non vede che sole?
— Vedo certe nuvole, laggiù… La scuola è lontana.
— Lontana, poi!
Il fanciullo indugiava. Sempre, prima di uscire, aveva una gran voglia di lasciare una parola buona alla sua mamma; ma non sapeva che dirle. Come avrebbe voluto che tutti fossero in pace tra di loro!
— Vada sul terrazzo! – esclamò. – Faccia prendere un po’ d’aria all’Agatina che non esce mai! È una giornata così bella!
Uscì, sbattendosi dietro l’uscio, per far rumore, per scuotere un po’ la casa troppo silenziosa. Per le scale cantò a piena voce, saltando gli scalini a quattro a quattro. E poi gli parve di slanciarsi, fuori del vicolo, nella strada piena di sole e di movimento.
— Ecco papà! – avvertì Agata.
Antonietta si alzò e andò in cucina per aiutare.
Mentre don Lucio era in casa, le due donne si studiavano di non mostrare troppo apertamente l’odio che le divideva e nel quale erano costrette a vivere insieme, come due paia di forbici chiuse dentro una stessa guaina.
Antonietta, guarendo, aveva fatto delle violenti scenate. Ma don Lucio aveva saputo troncare ogni motivo di recriminazioni con due ragioni indiscutibili: primo che il torto stava tutto dalla parte di Antonietta la quale aveva spesso trascurato i propri doveri non sorvegliando abbastanza la sorella minore (che con le sue tenere smancerie avrebbe cavato gli occhi a un eremita!) e occupandosi più dei figli che del marito; secondo, che lui, don Lucio, col cuore così malato, sempre minacciato dalla morte, aveva bisogno di calma e di tranquillità assolute. I litigi tra le due sorelle, le scene della moglie, avrebbero trasformato l’esistenza in un inferno! Inoltre, le angustie della famigliola di Sant’Agata, il doversi raccomandare ora per una cosa ora per un’altra, avevano contribuito a chiudere la bocca di Antonietta, in presenza del marito. Antonio doveva venire in città per un concorso, Alfonso per sostenere gli esami di licenza liceale, la terra era stata ipotecata… E don Lucio era lì, pronto ad ospitare i cognati, a dare preziosi consigli alla suocera, persino ad imprestare somme non lievi, senza garanzia… Non aveva diritto a esser compensato almeno con un po’ di pace in famiglia?
Carmelina aveva apparecchiato, lentamente per guadagnare tempo, e Nicolina s’era affacciata due volte sull’uscio a dare un’occhiata al posto del cognato. Non vi mancava nulla: c’era la sua saliera, il porta-stuzzicadenti, l’astuccio col Tot, il piattino col salame da una parte e i panini di segale dall’altra.
— Siete pronte?
— Prontissime. A momenti si porta in tavola.
Cominciava a dar filo da torcere, Alessio! Nicolina propose:
— Indugio ancora?
— Sì, è meglio – rispose Antonietta senza guardarla.
Carmelina andava a guardar dalla grata che dava sulla scala. Tornava desolata.
— Non viene!
Si udì la voce di don Lucio, che da un pezzo faceva tintinnare il coltello contro il piatto, impazientemente.
— Insomma, si mangia o non si mangia? Chi si aspetta? Che novità è questa?
Portarono subito. Mentre Antonietta spezzava il pane per le bambine, don Lucio domandò accennando con un movimento del capo al posto vuoto.
— Dov’è andato?
— A scuola…
— A scuola! – ripeté don Lucio ironicamente alzando gli occhi a guardare il bell’orologio della parete.
Mandarono giù in fretta e furia la minestra, senza gustarla. Mentre don Lucio mangiucchiava ancora lentamente, con gli occhi socchiusi, le due sorelle corsero in cucina con la scusa di fare l’arrosto. Carmelina si agitava sulla seggiola, smaniosa di alzarsi per avvistare il fratello, tendendo l’orecchio ad ogni rumore della scala. Eccolo, viene… No, è la porta della vedova che s’apre, è un passo pesante nel pianerottolo, è qualcuno che picchia al secondo piano…
— La finisci? Non imparerai mai a stare composta? – ammonì don Lucio toccando il frustino che teneva infilato nella spalliera. Carmelina si rannicchiò tutta, come fosse già stata battuta.
Suonano. È proprio lui!
Sì, è Alessio, colorito accaldato; è stato sulla spiaggia coi compagni. Porta in tasca dei sassolini colorati che paion confetti, per le sorelline, e ne mostra qualcuno all’Agata. È ancora sudato, eccitato; pare che abbia del sole negli occhi splendenti.
— Taci, Alessio. Piano. Papà è in collera – mormora la zia.
La voce del padre che domanda duramente: – Dove sei stato? –, il silenzio della sala da pranzo che pare fredda, le facce angustiate delle donne, tutto lo rattrista improvvisamente.
Sedette, mogio mogio, e cominciò a mangiare avidamente. Lo scosse la voce del padre che tornava a domandargli tenendo infilato nella forchetta un pezzo d’arrosto biondo e fragante.
— Dove sei stato pre-ci-sa-mente?
— Siamo tornati per la via lunga, dalla parte della Palazzata.
— Non sai che alle cinque in punto devi essere qui?
Le bambine avevano finito da un pezzo. Erano impazienti di alzarsi, per vedere i sassolini che Alessio teneva in tasca assieme a qualche filo d’alga odorosa a qualche patella ancora umida. Sbirciavano il padre, aspettando il segnale del permesso, felici che egli non avesse rimproverato Alessio così duramente come si aspettavano. Agata scivolò per la prima dall’alta seggiola, cautamente, e sulla porta chiamò i fratelli agitando le manine. Carmelina si fece animo e domandò:
— Possiamo andare, papà?
— Andate. Ricordatevi che alle otto, quando vi chiamerò, i còmpiti debbono esser fatti.
Le bimbe respirarono. Via per la scala di legno che cigolava forte dal piacere di essere amata dai ragazzi, come diceva Alessio; via nelle stanze di sopra, sfogo e rifugio dei primi piccoli dolori, dei rumorosi giochi, delle libere risate…
— Corri, Agatina… Questo è il nostro castello! Alessio?! Che hai?
Alessio le seguiva lentamente, senza gioia.
Antonietta, avendo vuotato le materassine piccole, si preparava a batter la lana. Nicolina entrò per aiutarla, come se fosse stata chiamata. Tacendo legò un fazzoletto intorno al capo e cominciò a battere con una delle verghe. Pareva che si fossero accordate prima, sufficientemente, sul compito di ciascuna. Finito di battere si rialzarono nello stesso tempo, scossero la polvere e i fili rimasti attaccati ai grembiuli neri, e cominciarono a riempire il guscio bianco e rosso che giaceva in un canto, afflosciato, come un panno macchiato. Si affrettavano pensando di sbrigarsi prima del ritorno di don Lucio che voleva trovar sempre la casa in ordine e le donne pulite. Antonietta, disteso il guscio su due asserelle, lo riempiva con la lana che Nicolina le portava a bracciate. Era già stanca. Un po’ pingue e pesante ansimava per la fatica fatta. Nicolina andava e tornava con la lana sulle braccia senza riprender fiato. Riserbava a se stessa le faccende più faticose e risparmiava la sorella, quasi senza volerlo, seguendo l’abitudine di tanti anni. Spazzò il laniccio rimasto e vuotò una seconda materassina. Poi infilò un ago e, sempre tacendo, come d’intesa, cominciò a ricucire la lunga fenditura dalla parte opposta a quella cominciata a chiudere dalla sorella.
— Prendi lo sgabello – disse Antonietta alzando gli occhi e vedendo la sorella penosamente curvata. – È sul balcone. Come vedi, io mi sono seduta.
Sullo sgabello c’erano dei balocchi della bambina più piccola.
— Per piacere, Agatina, – fece Nicolina avvicinandosi al balcone – togli questa roba e dammi lo sgabello.
— È mio – rispose la bambina. – E non te lo do.
— Sgarbata! – esclamò Alessio, entrando. – Non glielo devi mica regalare! Se non ci sono altre sedie…
— Che m’importa? – replicò la bambina appoggiandosi con le due mani allo sgabello, per difenderlo. Poi strillò: – Non mi deve comandare lei! Questa è la casa di mamma! Non è la casa sua!
Nicolina vacillò. Antonietta si alzò, impallidendo, e afferrata la bambina per un braccio la trascinò fuori, nell’altra stanza.
— L’ha detto mamma! L’ha detto mamma! – strepitava Agatina, divincolandosi.
— Alessio! – comandò Antonietta. – Conducila sopra, con te.
Tornò a posto. Ma le mani le tremavano visibilmente, nel riprendere il cucito interrotto. Nicolina era ancora davanti al balcone, come l’avevano lasciata, con le braccia abbandonate lungo i fianchi.
— Ecco – disse rientrando – quel che hai ottenuto facendo arrivare i tuoi sfoghi alle orecchie dei tuoi figli. Ripetono le tue parole. Io sono un’estranea, una nemica, nella tua casa. Specie le bambine, specie quella più piccola… È cresciuta in mezzo ai nostri litigi, come in una culla di rovi.
Si nascose il viso tra le mani, tacendo.
Antonietta cuciva.
Nel profondo silenzio che riempì la stanza, passarono amare parole non dette.
I cuori delle due donne battevano violentemente, come quelli di due bimbi che aspettino il rombo del tuono dopo il lampo.
— È la verità – disse finalmente Antonietta. – È forse mia, la colpa? Tu dài scandalo alle mie creature con la tua presenza.
— Taci! Taci! Alessio può sentire. Oh, almeno lui, che m’ha voluto bene, da piccolo!…
— È sopra. Con Agata. L’ho sentito salire. E poi… Credi forse che non capisca? I ragazzi hanno gli occhi bene aperti, oggigiorno…
— Taci… – ripeté Nicolina tendendo l’orecchio.
No, Alessio non poteva sentirle…
Ma il fanciullo aveva lasciata la bambina occupata a ritagliare un giornale, ed era tornato, in punta di piedi.. Ascoltava, con la gola serrata da un nodo di pianto.
— Non c’è… – ripeté Antonietta.
Era in piedi anche lei. Eccitate dalla fatica si fissavano, sfidandosi. Rade volte accadeva che si trovassero affatto sole, faccia a faccia; allora un futile motivo, una parola imprudentemente sfuggita, un gesto, bastavano a fare svampare l’odio che covava nei petti, troppo a lungo represso. Si parlavano con voce sorda, stringendo i pugni, istintivamente.
Due macchie vermiglie, come due pennellate, tingevano il viso olivigno di Nicolina sugli aguzzi pomelli.
— Sì. La colpa è tua – accusò Nicolina. – Tua. Non d’altri. Tu mi hai rovinata. E ora mi vorresti scacciare? Non me ne andrò. No. Te l’ho detto. Da questa casa non uscirò viva. Ho sciupata qui la mia giovinezza fresca e spensierata, come un velo che si butta su una siepe di spini. Tu mi hai rovinata. Tu mi hai messa in bocca al lupo. Intorpidita dall’egoismo mi lasciavi sola, giornate intere, per servirlo. Ti faceva comodo, allora, ch’io facessi la serva a te ed ai tuoi figli? Ti faceva comodo? E non pensavi ch’io era una povera creatura fatta di carne, come te? Perché gli dovevi voler bene tu sola? Non potevo sentire allora, ora no! ora non più! ora non più!, quel che sentivi tu? Anche più fortemente di te? Non ci pensavi? E se ci pensavi, non eri più snaturata della più snaturata femmina?
— Io avevo fiducia in te – mormorò Antonietta. – Tu eri la mia sorella piccola. Eri Nicolinedda… Non ci pensavo. Non ci pensavo – ripeté dolorosamente, con un grido, stringendosi la fronte tra le mani. – Come potevo temere che il mio sangue dovesse tradirmi? Io non sapevo di scaldare un serpentello nel mio petto. Io ti dovevo guardare. Avrei veduto che la tua faccia non era quella d’una creatura buona. Guardati! Guardati nello specchio, sciagurata! Tu hai la faccia del peccato! la faccia ossuta e senza colore di chi tradisce il proprio sangue…
— Tua è, la colpa!
— Mia! Ma se tu fossi andata via subito, allora…
— Tua!
— …e i bambini erano ancora piccoli…
— No. Non potevo andarmene. Non potevo uscire da questa casa maledetta dal Signore. Io sarei andata via come un corpo senz’anima. Andarmene! Come un cencio logoro che non serve più! Come un limone spremuto che si butta in mezzo alla strada! Mia madre mi aveva affidata a te. Dovevo tornare avvilita, quando non avrei saputo fingere, di già vecchia senza aver vissuto la mia parte di vita. Essa mi avrebbe guardata con i suoi poveri occhi stanchi di piangere per piangere altre lacrime più cocenti. E i fratelli? Come mi avrebbero accolta? E Caterina? Caterina non conosce il male e non ha pietà di quelli che cadono.
— Vattene adesso. Vattene! Non è mai tardi!… Non sapranno niente, se tu tacerai. Dipende da te. Lasciami in pace, almeno ora! – ripeté Antonietta, angosciata. – Abbi pietà, non di me ma delle mie creature. Io sarei fuggita, sparita, mille volte, al tuo posto. Tu vuoi bene alle bambine eppure non hai scrupolo a dare scandalo alle loro anime innocenti…
— Non comprenderebbero, se tu, sciagurata, non ti facessi sentire… Tu hai persino sfogato dicendo male di me a Carmelina. No! – riprese. – Non me ne vado. Tu vuoi restare tranquilla nella tua casa, fra i tuoi figli! No! Trascinerai la catena con me. Io ho raccolto i resti del tuo benessere come Lazzaro alla tavola del ricco Epulone. Mi scacci per restare in pace? E che diritti hai tu alla tua pace? Non è già troppo ch’io – io che allora l’adoravo senza saperlo, – io che lo servivo con più devozione di te…
S’interruppe guardandosi intorno smarrita. Si sentiva girare la chiave nella toppa. Dovevano essere le quattro e mezza.
Alessio scomparve. Le due sorelle tentarono con le mani gelate e tremanti, di riprendere il lavoro. La casa tornò a immergersi nel silenzio come l’acqua di un lago che si ricomponga adagio adagio.
Don Lucio si mostrò in mezzo all’uscio, lungo lungo vestito di verde.
— Siete ancora qui? – brontolò, scontento.
Antonietta andò in cucina. Nicolina portò le pantofole davanti la poltrona del cognato; poi si decise ad entrare anch’essa in cucina.
Alessio s’era rifugiato nella stanzetta di già in penombra. Con la testa tra le mani piangeva sconsolatamente. Il suo piccolo cuore era gonfio di pietà verso la madre, di pietà verso la zia. Due volte si era fatto animo per entrare e metter pace fra le due sorelle, con qualche buona parola. Ma non aveva osato. La sua presenza avrebbe recato nuovo e maggior dolore all’una e all’altra.
Non poteva intromettersi. Era ancora un fanciullo, lui, un povero fanciullo che non deve capire, che non deve giudicare «quelli che sono più grandi». Provava uno sgomento, un avvilimento, profondi; pareva che il mondo si fosse scolorato all’improvviso e ogni speranza, ogni cosa bella, fosse svanita in una sconfinata tristezza.
Le rade scene a cui assisteva non visto, non le dimenticava mai più. Anche nelle ore più luminose, sempre scorreva nella sua anima adolescente una sottile tenace vena di malinconia.
C’era, sì, c’era qualche cosa che faceva brutta la vita! come una macchia che non ci riesce di cancellare.
— Alessio! Vieni a tavola!
Si scosse, sbalordito. Si lavò il viso per fare sparire le tracce delle lacrime.
Sedette al proprio posto e mangiò in silenzio, senza voglia. Aveva gli occhi rossi, e i fini capelli, ancora bagnati, appiccicati sulle tempie diafane. Ma don Lucio, assorto a masticare lentamente per digerire bene, non badò a suo figlio. Anche le due sorelle, ancora un po’ eccitate, non badarono ad Alessio.
In casa preparavano le salsicce sotto la guida di don Lucio che se ne intendeva.
Aveva la macchinetta per tritare la carne, e custodiva un pezzetto di sughero attraversato da una ventina o più di spilli per punzecchiare i rocchi pari pari. Quando veniva il tempo delle salsicce, ogni dicembre, non c’era bisogno di cercare spilli o spilloni disadatti che bucano e sciupano tutto, come si fa in tante case.
Aveva dosato e pesato lui, con le proprie mani, il sale il pepe il finocchietto; e ora che la pasta era pronta e le donne insaccavano, badava a pungere convenientemente col suo pezzo di sughero. Anche le bambine si divertivano ad aiutare, rallegrate dalla novità. Pareva già festa. È sempre così quando il Natale si avvicina e la credenza si ricolma di provviste.
Solo Alessio mancava. Era il suo ultimo giorno di scuola e ritardava, al solito.
Se l’avesse visto zia Nicolina! Perdeva tempo, quasi senza avvedersene, per il piacere di perder tempo. Si divertiva a lasciarsi portare avanti dalla folla, nella strada in movimento, come un filo di paglia abbandonato alla correntia del fiume. Qui si fermava per guardare una quantità di giocattoli che non lo potevano interessare: lì s’incantava a guardare due uomini che incollavano un manifesto grande quanto un lenzuolo; più lontano si cacciava in mezzo a una calca per sapere che fosse successo. Infine rimase un pezzo assorto a contemplare una mostra di libri vecchi. Voleva comprare Le vite degli uomini illustri, ma non aveva i quindici soldi che ne domandava il venditore.
— Un’altra volta… – disse un po’ confuso, allontanandosi.
Giunto presso casa affrettò il passo. Alla cantonata gli si fece innanzi una donna vestita di nero, dalla faccia scarna e rugosa, ardente come la faccia d’una zingara. Volle scansarla. Ma la donna lo fermò.
— Non abbia paura d’una povera sventurata. Lei è il figlio di don Lucio Carmine?
— Sì.
— Dell’uomo di fiducia del barone Rossi?
— Del segretario, volete dire?
— È lo stesso. Senta. Lui, il suo papà non mi vuole ascoltare. L’ho pregato come si prega un santo sull’altare e mi ha scacciata via. Stia a sentirmi lei, per l’amore che deve portare alla sua mamma. Tre mesi fa gli consegnai, nella sala a pianterreno della Casa de’ Venti (dove lui sbriga gli affari), la collanina della mia povera figlia, in pegno. È una collanina assai antica e bella… Lui si voleva garantire… Mi promise che mi avrebbe lasciato riscattare il gioiello, quando avessi avuto i denari, senza limite di tempo. Gli ho portati i denari – due onzi in tutto! si figuri! – e mi ha risposto che l’obbligo suo durava due mesi e la collana non l’ha più! Ah! che schianto, signorino! Glielo dica lei. Ha la faccia d’un piccolo Sant’Antonio, lei, e il suo cuore non può essere cattivo…
— Ma io non capisco. Papà non può avervi prestato dei denari!
— Magari non me ne avesse mai prestati! Magari mi fossi rivolta a uno strozzino! Almeno non sarei stata avvolta nell’inganno.
— Non vi credo.
— Che la Madonna mi privi della vista degli occhi se io mentisco! Che io non riveda il Santo Natale se il fatto non è vero.
— Non può essere – esclamò Alessio, e di nuovo volle allontanarsi.
Ma la donna gli afferrò una mano e gli parlò a lungo, fissandolo con occhi ardenti di preghiera di dolore di odio.
— Dirò la cosa a papà – concluse Alessio, un po’ spaventato dallo sguardo di zingara della sconosciuta. – Non credo che vi abbia prestato denari. Assolutamente non credo. Ma io gliene parlerò. Sì, anche a costo di farmi battere gli dirò quel che mi avete raccontato. Se è vero – mormorò tra le lacrime, – voi riavrete la vostra collana. Ma come debbo dirgli per farvi riconoscere?
— Oh! lui lo sa! Gli dica Maria del vicolo dei Tre Re. La collana non la può confondere. È antica. In mezzo c’è una crocetta d’oro lavorata con le pietre rosse, così rosse che paiono gocce di sangue. Lui lo sa. Altro se lo sa!
Alessio fece le scale di corsa. Fu rimproverato.
— Dove sei stato pre-ci-sa-mente?
Non badò ai rimproveri. Più tardi non rammentò che cosa avesse risposto per giustificarsi. Era stordito. Nella mente gli turbinavano le parole della donna. Pensava: «Come gli dirò? Come gli dirò?».
E incontrando lo sguardo assonnato e tranquillo, abbassava gli occhi trasalendo.
«Non può essere vero! – ripeteva fra sé e sé. – Non può essere. Io non avrò il coraggio di aprire la bocca».
Lottò dentro di sé tutta la serata, come un uomo. Andò a letto senza aver parlato.
— Buona notte. Mi benedica… Mi benedica…
L’indomani respirò quando il padre uscì per i propri affari. Poi fu impaziente che tornasse. Fu di nuovo sera e lui non aveva aperto bocca. Nicolina accese la lampada. Antonietta portò la cartella coi registri sulla tavola… La casa era piena di pace.
«Solo io, solo io – pensava Alessio – ho il fuoco dentro l’anima».
Era necessario parlare, sfogare quella pena cocente. Forse era meglio domandar consiglio alla madre.
«Lui non mi perdonerà mai di aver creduto alle accuse di una donna di strada».
Ma bastava dire le cose come stavano, mostrando di non aver creduto.
— Papà! – esclamò risolutamente. Ma la voce gli si spezzò in un singhiozzo.
— Aspetta un momento – fece don Lucio posando la pipa ed alzandosi.
— Va a prendere il regalo! – mormorò Carmelina arrossendo dalla gioia – Me l’ha promesso ieri.
Don Lucio tornava con un piccolo cartoccio. Lo svolse adagio adagio, tenendo sospesa la curiosità delle donne.
— Com’è bella! – esclamò Antonietta.
— Com’è bella! – ripeté Nicolina.
Alessio si alzò a guardare, si fece bianco come la cera.
— No! No! – gridò, agitato da un tremito convulso. – Non gliela dia, papà! Gliene supplico!
Don Lucio teneva fra le mani, sospesa, una fine collana d’oro antico, una crocetta d’oro con le pietre rosse.
— Tu ti senti male! – disse Nicolina, obbligandolo a sedersi. Ma Alessio si rialzò in piedi, con uno sforzo.
— No. Non gliela dia!
Tremava tutto, esasperato dall’agitazione contenuta per ventiquattro ore.
— Infine?! – esclamò don Lucio battendo un pugno sulla tavola minacciosamente. – Si può sapere che hai?
— Non lo spaventare – pregò Antonietta. – Deve essere malato. Vedi com’è stravolto?
— Se è malato si curi. Se è pazzo vada a chiudersi in un manicomio.
— Non sono malato. Non sono pazzo – esclamò Alessio. E con voce rotta raccontò la scena del giorno innanzi, senza dimenticare una parola, perché ogni parola gli era restata impressa nella mente.
Don Lucio l’ascoltò senza interromperlo, senza alterare un muscolo della faccia. Era necessario lasciargli dire tutto, non insospettirlo…
Ma quel ragazzo che tutto scopriva, tutto indagava, era un piccolo temibile giudice.
Facendo uno sforzo su se stesso accarezzò il figlio e spiegò a lui e alle donne che la collana l’aveva comprata, nella bottega d’un antiquario, pagandola assai cara.
— Maria del vicolo dei Tre Re…
— Sì, Maria del vicolo. La conosco. Un tempo serviva in casa del notaio. Per questo la conosco. Me l’ha vista comprare. Vuole speculare sopra un ricatto. È una poco di buono, una ladra. Ha avuto da fare con la giustizia. La città è piena di questa gente. Si è rivolta a te, che sei un ragazzo e non capisci nulla… Lo so io che devo badare a una trentina e più di pianterreni appigionati a figuri come Maria del vicolo dei Tre Re… Me ne passano fra le mani! Io te l’ho sempre raccomandato: non bisogna fermarci a parlare con la gente che non conosciamo!
Parlava tra i denti per frenare la collera. Alessio restava accasciato: le orecchie gli ronzavano; infine non comprese più nulla; lo portarono a letto, come un bambino. Fu colto dalla febbre.
— Febbre nervosa – affermò don Lucio che l’indomani salì a vederlo. – Imparerà a saper vivere.
Per due giorni, finché durò il delirio, restò accanto al letto, del malato: aspettava che gli sfuggisse qualche parola taciuta.
Alessio non sapeva altro che quello stupido fattarello della collana. E don Lucio si rasserenò; ma non riuscì a vincere la sorda diffidenza che gli ispirava suo figlio, l’unico che sfuggisse alla sua vigile sorveglianza.
Il gioiello sparì nella cassetta di mogano; e Carmelina pianse per il regalo perduto. E sparì anche la cartella della scansia presso il balcone; la sera don Lucio si alzava per andare a prenderla da un cassetto chiuso a chiave.
Alessio, dopo le feste non liete del Santo Natale, tornò a scuola, indebolito dalle febbri, e non incontrò più seccatori.
Era mortificato di avere creduto; pure il dubbio, piccolo, insistente, continuò a tormentarlo per qualche tempo.
Temeva, specie verso il crepuscolo, di incontrare la donna vestita di nero, dalla faccia di zingara: doveva esser lì, incollata al muro, ad aspettarlo, con gli occhi nerissimi e ardenti, pieni di odio e di preghiera.
Ma suo padre non aveva mentito. Lo rivedeva come quella sera, tranquillo, persuasivo, un po’ offeso, un po’ indulgente… Non aveva mentito.
Ma dove era sparita la collana? Perché non darla più a Carmelina, se era stata comprata?
Il solo ricordo della crocetta d’oro antico, lavorata con le pietre rosse, così rosse che parevano gocce di sangue, gli incuteva orrore.
Don Lucio partiva, per la sua solita visita annuale, per verificare e regolare gli affari del barone; in ultimo doveva andare anche a Catania a far visita alle sue sorelle maritate, che lo facevano ripartire carico di provviste e di regali. Da quando si era assicurato che le sorelle non gli avrebbero dato noie, se ne ricordava ogni anno con una certa amorevolezza.
— Eh! Eh! – diceva, persuaso di essere sinceramente commosso. – Eh! Il sangue non è acqua!
E così dicendo, si sforzava di fare entrare nelle valigie e nelle sportelle tutte le conserve, tutta la frutta e il pan di Spagna che le sorelle mandavano alle nipotine che non conoscevano ancora. In quei momenti, anche loro dimenticavano l’abbandono in cui le aveva lasciate l’unico fratello, nel tempo che erano rimaste orfane e senza avvenire…
Tutto era pronto per la partenza. Le bambine, che non erano state mandate dalle monache per salutare il padre, si divertivano a rincorrersi nella piccola corte dove Alessio aveva trasportato le valigie, due grandi valigie di cuoio nero coperte dalle fodere di tela iuta su cui spiccavano le iniziali «L. M. C.» ornate di ramoscelli rossi e gialli.
Le donne, piangendo come ogni anno, trattenevano un poco don Lucio, davanti l’uscio, per affidargli i saluti da portare a quelli di Sant’Agata. Nicolina, afferrata una mano del cognato, la copriva di baci nel ripetere un nome caro, un nome che faceva male al cuore ogni volta che lo pronunciava forte.
— La mamma… Dite così, alla mamma…
Antonietta non si offendeva che la sorella salutasse il partente con l’appassionata tenerezza con cui lo salutava lei stessa. Era un momento di fugace e profonda sincerità, in cui l’una leggeva dentro l’anima dell’altra.
Non piangevano per lui, oh! no! Intensamente pensavano ai luoghi che lui avrebbe riveduti e che non ristoravano i loro occhi da tanti anni. E alla nostalgia del passato, che gonfiava i loro petti, si mescolava un filo di paura dei giorni da venire. La paura di restar sole, l’una di faccia all’altra, come due colpevoli chiuse nella stessa cella – senza scampo.
Don Lucio assente, i ragazzi a scuola, finiva ogni ragione di tacere. I litigi scoppiavano più violenti, più frequenti. Qualche giornata trascorreva in calma se Nicolina restava chiusa nella propria cameretta, in piccionaia, e Antonietta nella stanza in fondo alla casa. Allora si vedevano nell’ora dei pasti; accadeva che non si vedessero neppure in quelle ore perché, mancando il capo di casa, non pensavano a cucinare tutti i giorni, ma prendevano un boccone in piedi, tra una faccenda e l’altra. Giorni di quiete dolorosa, di silenzi snervanti, o giorni d’inferno, erano quelli che le aspettavano…
Si sentiva l’impaziente schioccar della frusta, fuori.
— Lasciatemi andare – disse don Lucio, e cominciò a scendere le scale, accompagnato. Le donne sapevano che giunto al penultimo pianerottolo, don Lucio si sarebbe voltato e però a un certo punto si fermarono. Egli si fermò al penultimo pianerottolo e si voltò mostrando la fronte breve corrugata, sotto il berrettino a dadi.
— Che giorno è oggi?
— Sabato – rispose Antonietta.
— Ne abbiamo quindici – aggiunse Nicolina.
Don Lucio guardò il taccuino, dov’era segnato tutto l’itinerario del viaggio, e annunciò:
— Sarò qui il trenta del mese venturo col treno delle sei e venti.
E riprese a scendere.
Egli, che divideva il tempo con precisione matematica, non credeva agli avvenimenti imprevisti che affliggono tanti uomini. Se aveva detto il trenta sarebbe tornato il trenta, col treno delle sei e venti, giungendo a casa, in legno, alle sette. Voleva trovare il brodo e l’arrosto, la biancheria pulita preparata a piedi del letto, l’acqua calda per lavarsi.
Baciò le bambine e, dopo avere ripetute alcune raccomandazioni con voce monotona, baciò Alessio. Abbracciò la moglie e poi, senza esitare, strinse gravemente la mano della cognata, baciandola fraternamente sulla fronte. Allora Nicolina proruppe in nuove lacrime, e il suo esempio fu seguito, come un’eco, da Antonietta e dalle bambine.
Ecco che restavano veramente sole.
— Addio! Addio!
— Ci benedica, papà…
La scala risonò di singhiozzi.
Ebbene, dopo tutto, era l’unica persona che le amasse davvero…
«È colpa sua? – si domandava Antonietta risalendo. – È colpa sua se il destino ha voluto che lei si attaccasse alla sua vita come un debole filo che intrica i rami d’un albero? E lei non ha forse espiato?».
I loro cuori erano riboccanti dello stesso sentimento di pietà. L’una avanti, l’altra dietro – nella scala – ebbero lo stesso impulso: parlarsi senza ambagi, con umanità, poiché erano state tutte e due ingannate dalla vita, e si dovevano perdonare…
Ma richiudendo la porta, che girando sui cardini cigolò sordamente, le colse lo stesso gelo, l’insanabile rancore le armò di nuovo.
Agata saltellava nella saletta, spingendo la sorellina, felice che il padre fosse partito e che per un pezzo potessero fare il chiasso liberamente, senza la minaccia del terribile frustino.
Nicolina fu morsa dall’ira, quasi che l’irrefrenabile allegria fosse provocata dalle sue lacrime non giustificabili.
— Senza cuore! – gridò, scotendo Agata brutalmente. – Papà non è ancora giunto alla stazione e tu ridi di già!
Corse a rifugiarsi nella propria camera per poter piangere le sue lacrime – a cui non aveva diritto in quel momento senza essere giudicata e derisa.
Agata, la più piccola, quella che aveva succhiato il rancore contro di lei col latte della madre, la derideva… Sì, la derideva…
— Dunque? – ripeté Alessio, insistente.
— Non so… Papà non c’è… Pare che vogliamo approfittare della sua assenza…
— Per fare una innocente passeggiata? – concluse Alessio. – Via, mamma, non esageri così! Si decida, almeno per le bambine che non vedono mai un po’ di sole! Quando papà c’è, manca il tempo. Quando non c’è…
Antonietta non rispose. Le sorrideva l’idea di chiuder la porta e uscire con i suoi figli, spensieratamente. Ma vedeva la difficoltà di mettersi d’accordo con la sorella che l’avrebbe mal giudicata, che forse l’avrebbe accusata di leggerezza quando don Lucio fosse tornato.
— Ebbene – disse finalmente, e parve che un velo abbuiasse il suo viso pallido e floscio. – Conduci con te tua zia. Non vorrei che tuo padre trovasse la porta chiusa, tornando.
— Papà non tornerà oggi – esclamò Alessio correndo a chiamare la zia.
Nicolina si lasciò trascinare, sorridendo, in camera.
— Lasciami, Alessio! Dove mi conduci?
Era contenta che il nipote la costringesse ad entrare nella camera della sorella.
Anche Antonietta che udiva lo scherzoso contrasto, era lieta che il figlio si mettesse fra di loro, come un angelo di pace.
Pure Nicolina, mettendo piede sulla soglia, si pentì di essere entrata, mentre Antonietta si irrigidiva senza volerlo.
— Alessio mi ha trascinata fin qui – spiegò, confusa. – Dice che dobbiamo uscire.
— Se credi di contentarlo – fece Antonietta senza levare gli occhi – …La giornata è buona e le bambine non vanno a scuola…
— Che dovrei mettere? – domandò Nicolina dopo qualche minuto di silenzio. – La veste da estate?
— Sì! – rispose Alessio vivacemente. – Son tutti vestiti di chiaro, ormai.
Le due sorelle impiegarono molto tempo a vestirsi perché non erano abituate ad uscire e non trovavano subito tutti i piccoli accessori necessari. Ci fu un momento di disordine.
— Agata! fatti dare il calzatoio!
— Domanda alla mamma dove sono i guanti!
— Carmelina! Corri a prendere la sottana, deve essere nell’armadio della zia.
E poi, cinture che non arrivano, bottoni che saltano quasi volessero fare un dispetto, e maniche gualcite che vorrebbero essere stirate…
— Le vesti leggere e i cappelli da inverno! – mormorò Nicolina, scontenta, guardandosi nello specchio.
Cercarono ancora qualche cosa dimenticata, lamentandosi di aver perduto troppo tempo, di essersi decise a uscire troppo tardi.
Finalmente furono pronte. Finalmente si staccarono dalla casa.
Per un tacito accordo Antonietta restò indietro con le bambine. Nicolina passò avanti col nipote che era tutto superbo di aver condotto fuori la famiglia, come un uomo grande, e si voltava ogni tre passi a sorridere alla madre con l’aria di dirle: «Vado con la zia per non lasciarla sola, ma verrei tanto volentieri anche con te!».
Il suo piccolo cuore era sempre riboccante dell’accorata inesauribile voglia di vedere d’accordo la mamma e la zia.
Pensava: «Quando sarò grande e avrò la moglie e i figli, li condurrò a spasso ogni giorno e spenderò, per farli godere, tutti i soldi che guadagnerò!».
Qualcuno si voltò a guardare la piccola comitiva. Due giovanotti sorrisero e l’uno disse:
— Sono scappate dal figurino della bisnonna…
In verità le due signore non vecchie, dai goffi abiti a svolazzi e falpalà, le cappotte di velluto a cuffia, stonavano nello sfondo vario e animato della strada.
Perché era proprio l’ora del passeggio… Purtroppo…
Alessio si vergognò. Cercò, senza riuscirvi, di allontanarsi dalle strade belle, troppo frequentate, e non parlò più. Sentiva che le sue donne erano vestite male, e se passava a fianco d’una signora elegante, abbassava gli occhi arrossendo.
«Perché? – si domandava con amarezza. – Perché noi dobbiamo essere quasi reietti? Perché la nostra vita deve essere così grigia e povera, come un’ombreggiatura, mentre il mondo è bello, luminoso, e gli altri sono tutti felici?».
E andava umiliato e smarrito, a testa bassa, pentito di aver condotto fuori la famiglia. La Palazzata gli pareva più grande e più splendida, la via più vasta, più affollata del solito, e gli pareva che il Nettuno dall’alto lo guardasse con compatimento.
Giunti sulla spiaggia libera, in un punto quasi deserto, si rinfrancò. Il mare sconfinato e misterioso, calmava sempre il suo piccolo cuore.
Più lontano, dove la gente continuava a passeggiare, il mare era differente.
— Mi farò marinaro – disse forte, chiudendo un suo rapido pensiero.
— Iddio ce ne scampi! – esclamò Nicolina sedendosi su di un sasso. – Una vita piena di pericoli!
— Io sarei veramente disperata – aggiunse Antonietta, – se ti sapessi in mezzo al mare.
— Tanto! – fece Alessio.
Voleva dire: «Tanto! io dovrò essere ingegnere!».
E di nuovo lo scontento gli serrò il petto. Ma subito il piacere che gli dava la vista del mare brillò nei suoi grandi occhi di fanciulla.
Tacquero tutti e tre, assorti in una calma piena di tenerezza. Le bimbe si divertivano sulla sabbia, a raccattar sassolini, conchiglie, cacciando piccoli gridi di gioia nello scoprire tutte le cose bizzarre che il mare getta e riprende con vasto mormorìo.
— Guardate – disse Alessio. – C’è un brigantino, laggiù.
E gli occhi delle due sorelle si posarono sul punto chiaro e lontano che Alessio aveva chiamato brigantino. Il pensiero pareva sospeso, nell’aria luminosa, come pulviscolo d’oro. Tutte le piccole miserie che sembravano grandi, l’aspro rancore di cui era satura l’aria della casa nel vicolo e che esse portavano chiuso nei cuori, parevano dileguarsi e sparire nella serena lontananza del cielo aperto. Tutto era piccolo e lontano, come il brigantino che passava sul mare.
Il crepuscolo li colse, immobili e smemorati, nello stesso posto. Videro il sole affocato immergersi nel mare, in mezzo a una violenta luce purpurea che smoriva piano piano. Gli strilli delle bambine – ebbre d’aria e di libertà – si rincorrevano ancora sul greto. L’ora si colmava di malinconica dolcezza.
— Mi farò poeta… – disse Alessio.
Nicolina rise.
— Tu cambieresti mestiere cento volte cento. Meno male che alcuno ti guida!
Alessio corrugò la fronte, ferito dal tono di quella voce troppo nota, che lo riconduceva nella realtà delle cose mentre più credeva di essersene distaccato.
Fecero la via del ritorno, tutti in fila, poiché la strada non era frequentata.
— Che bella passeggiata ci hai fatto fare! – disse Antonietta.
— Dovremmo ripeterla, anche quando sarà tornato Lucio. Saremmo tutti più buoni. Stasera provo un benessere, una pace, come se avessi fatto un bagno caldo.
Risero allegramente, anche le bambine, al paragone di Nicolina.
Presso casa le due donne provarono una specie di apprensione. Affrettarono il passo quasi che avessero dovuto trovare don Lucio impazientito e seccato. Salirono le scale di corsa. Si svestirono in fretta quasi che don Lucio avesse dovuto rimproverarle di essere uscite senza avergli preparata la pipa e la limonea.
Era l’abitudine grigia e metodica di tanti anni – dalla quale non si sarebbero mai liberate.
Corse verso la spiaggia, andò sulla scogliera amica, cautamente. Gli piaceva andare sull’estremo scoglio e sentirsi spruzzare nel viso e nelle mani qualche ondata di spuma. Rimase un pezzo accoccolato, immobile, col mento fra le mani, seguendo le candide ondate che correvano, una sull’altra, in fretta, in furia, spezzandosi contro la riva bruna.
Era crucciato e non sapeva di che. Forse di nulla. Forse di tutto. Viveva una delle sue ore desolate, in cui l’anima trasaliva ad ogni piccola fugace impressione, come una corda di violino che vibra e geme se un dito la sfiora. Presso la scuola un girovago suonava l’organetto; era fuggito via per non sentire, con una impetuosa voglia di piangere.
Si calmava a poco a poco, davanti al mare buono e senza limiti.
C’era sì, c’era qualche cosa che faceva brutta la vita.
Un sentimento di dolore e di vergogna gli attanagliava l’anima. Fugaci immagini ripassavano davanti gli occhi intorbidati dalle lacrime. Ecco zia Nicolina, attaccata alla casa come il fitto lichene che s’attacca allo scoglio e non lo lascia respirare. Ecco Maria del vicolo che lo perseguita col suo sguardo cupo di collera.
Ah! potere sfogare quel turbamento che si alimenta di nulla, che sciupa l’anima, come la ruggine che intacca un metallo nuovissimo!
Forse si ingannava. Forse giudicava a torto perché era inesperto. Non sapeva distinguere ciò che è buono da ciò che è cattivo e credeva colpevoli le azioni più naturali, come un bimbo, chiuso in una stanza allo scuro, ha paura degli oggetti familiari.
Come invidiava, talvolta, al suo compagno prediletto, quel padre che accoglieva indulgente ogni piccola confidenza, che dolcemente s’interessava dei libri, degli amici, delle scappatelle, di tutte le cose belle e brutte che formavano l’esistenza del figlio! Quante volte aveva sentito, irresistibile, il bisogno di parlargli!
— Signor barone! – le prime parole gli venivano pronte sulle labbra. – Sono un povero ragazzo che non capisce niente…
Un ragazzo che soffre ed ha paura, perché sente serpeggiare nel sangue, come un male nuovo, i primi istinti dell’adolescenza. Un ragazzo ancora, che la sera ha bisogno del bacio della mamma, e più ha bisogno che il padre lo conduca verso la maschia vita, adagio adagio…
— Signor barone…
Il pensiero correva alla zia, alla collana… E se le cose che avrebbe detto avessero nociuto a qualcuno? Bisognava tacere, poiché non sapeva distinguere ciò che è buono da ciò che è cattivo.
Ma soffriva veramente per i dissidi familiari, per il dubbio che il padre avesse prestato del denaro a usura? No, no. Lo scontento era dentro di sé, come un sapore amaro.
Aveva letto: «Noi portiamo il paradiso o l’inferno dentro il nostro cuore». È ingiusto che chi non ha mai fatto male ad alcuno debba portare l’inferno dentro il cuore.
Ora che andava al ginnasio non si confessava più: si sarebbe vergognato a mostrarsi in chiesa. Ora studiava «l’evoluzione della specie», imparava che l’uomo deriva dalla scimmia e che il cielo non è altro che aria. Anche codeste verità, spiegate dalla cattedra, dall’autorevole professore Friland sconvolgevano il suo spirito. Qualche anno innanzi, il professore Zermani spiegava diversamente le stesse cose, col medesimo tono che non ammette dubbi. Ebbene – si domandava Alessio – chi conosce la verità?
Certo, – si rispondeva – il professore Friland che parla a fanciulli più maturi… Certo… Ma anche il professore Zermani era un uomo adulto e intelligente. Aveva consumato la giovinezza sui libri per imparare degli errori? Soltanto degli errori?
Ma perché, poi, dovevano essere degli errori?
Levava gli occhi. Sul cielo splendente non passava una nuvola. E oltre quella splendida azzurra serenità non c’era nulla?
Guardò il mare, e pensò con un brivido alla smisurata profondità degli abissi. – No, – ripeté forte, – non può essere che al di là del cielo non vi sia nulla!
— Dice a me, signorino?
Un vecchietto magrissimo, in maniche di camicia, era nell’acqua fino a mezza gamba.
— No, no… – esclamò Alessio arrossendo, mentre tutte le sue fantasticaggini fuggivano via come un volo di api nel sole. – Che cosa cercate?
Il vecchietto cacciò una mano nella tasca dei calzoni e mostrò un riccio, una manata di patelle. Senza parlare le offrì.
— Vuole che le apra?
— Grazie! Ma io non porto niente… No ho che due soldi. Accettateli.
Il vecchio prese la moneta sorridendo, e con un piccolo coltello aprì il riccio. Sempre sorridendo ne aprì un altro, offrendo i vividi spicchi rossi nel mezzo guscio nero con gesto lento e calmo.
— Ci sarete domani? Io vengo, ogni giorno, dopo la scuola.
— Sì, ci sarò – rispose il vecchio, ripigliando a cercare fra gli scogli.
— Siete pescatore?
— No. Sono contadino. Ma non posso lavorare perché ha piovuto troppo. Vengo qui. Il mare fa bene alla salute e regala sempre qualche cosa.
— Mio figlio è in America – aggiunse. – Non gli piaceva più stare con me.
— Perciò siete solo con vostra moglie?
— Sono solo. La moglie non l’ho più. Avevo dieci figli, tra maschi e femmine. Ora chi è morto, chi si è maritato, chi è all’America, e son rimasto come un ramo senza foglie. Sia fatta la volontà di Dio!
E il vecchio sorrise dolcemente, rassegnatamente, allargando le braccia.
Forse sorrideva ai cari morti.
— Vi saluto, buon uomo – fece Alessio, saltando in piedi.
— Bacio le mani, signorino. Perdoni se le dico una cosa. Poco fa l’ho veduto afflitto come un passero con le ali tagliate. Ebbene, chi è giovane deve stare allegro.
— E se essere giovani non serve a niente?
— Come può dire queste cose se non ha i capelli bianchi? La giovinezza è sempre buona. Bacio le mani, signorino.
Doveva essere tardi. A casa fu sgridato. Ma Alessio non si curò della cattiva accoglienza che gli fecero. Aveva nelle orecchie la voce cadenzata del vecchio contadino, e nel cuore una quieta voglia di essere buono.
Ecco che le sciagure erano passate sul capo del vecchio contadino e non per questo il suo sorriso aveva perduto l’infantile dolcezza e i suoi occhi la espressione rassegnata della Fede.
Pareva che egli conoscesse le umili profonde verità della vita.
«Tornerò da lui – pensò Alessio –, ed egli sarà il mio amico».
— Zia! – chiamò Alessio entrando nella stanza da pranzo con un pacco di libri e di rassegne illustrate che aprì quasi in fretta.
Nicolina si avvicinò alla tavola, asciugandosi le mani nel grembiale da cucina.
— Che mi fai fare, Alessio! A momenti è l’ora di cena!
Ma così esclamando si chinò a guardare le magnifiche illustrazioni, con festosa curiosità.
— Guarda che viale!
— E questo?
— Oh! com’è bello quest’angelo! Gli manca la parola! Aspetta, Alessio, lasciamelo guardare ben bene. Melozzo… Si chiamava Melozzo?… Che nome strano!
— Melozzo è il nome del pittore.
— Beato chi possiede tutte queste belle cose!
— Non è vero, zia? Il mio compagno Rossi ha uno scaffale così grande, pieno di libri e di rassegne.
— Fattene prestare, a poco per volta. Ora che viene l’inverno con le serate lunghe ci svagheremo.
— Ti ho portato anche un bellissimo libro di Turghèniev. Si chiama Pane altrui. Ti ricordi di Turghèniev? È l’autore di Acque di Primavera che ti piacque tanto. Ma non mostrare a papà i libri che mi procuro per te!
— Non temere.
— Mamma! Perché non vieni anche tu a vedere?
— Vengo, Alessiuccio! – rispose Antonietta che passava portando della roba nell’ultima stanza. Ma non si affrettava. Non avrebbe goduto, restando a fianco della sorella.
Nicolina dimenticava persino le faccende. Accanto al nipotino ricuperava la letizia dell’adolescenza così presto fuggita. Via via che Alessio cresceva, Nicolina si illudeva di vivere una seconda volta. Senza saperlo egli le mostrava un mondo nuovo, fin allora ignorato.
I libri che le portava, le cose belle che le mostrava, i discorsi che le faceva, contenevano vivide rivelazioni di una vita spirituale assai più nobile ed elevata della «vita di tutti i giorni» che essa trascinava meschinamente, come chiusa dentro un bigio alone di nebbia. La vicinanza della gentile e pura fanciullezza di Alessio, ristorava la sua anima chiusa e inaridita. Egli era pieno di entusiasmo e di sentimento; bastava poco per farlo godere e pochissimo per farlo soffrire, come un uccello che gorgheggia di felicità se un raggio di sole indora i ferri della gabbia, e tace, immalinconito, appena l’aria s’annera…
— E questa scena, Alessio?
— Rappresenta l’interno di un harem. Usanze dei turchi che non hanno una moglie sola.
Don Lucio comparì in mezzo all’uscio, lungo lungo col pastrano ancora abbottonato, un po’ stizzito perché nessuno l’aveva sentito entrare. Restò un momento a guardare zia e nipote che voltavano le spalle all’uscio. Nicolina, guardata così, era ancora giovanissima. La nuca delicata pareva incipriata; i capelli bruni, che si mescolavano a quelli chiari e fini di Alessio, avevano lucidi riflessi, come piume di storno. La visione di quella fresca giovinezza, per un momento felice perché spensierata, aggravò la sua stizza. Egli era già vecchio. Forse per questo, da un pezzo, non si interessava più della cognata.
Restava piantato in mezzo all’uscio, con la fronte bassa corrugata. Lui non si era mai entusiasmato così a guardare delle figure insignificanti. Invidiò la loro gaiezza astiosamente. Si divertivano perché erano spensierati, ecco tutto. Non sapevano quanto costi aprirsi una strada ben comoda, nella vita, e coglievano i frutti delle sue fatiche senza occuparsi più di lui… Erano come i cavalli da tiro che mangiano con la testa nel sacco…
Credette di sentir battere troppo violentemente il cuore, e si allarmò.
— Togli via questa roba! – comandò avvicinandosi alla tavola. – Ti ho detto mille volte di non ingombrarmi la casa di cartacce. Del resto – aggiunse – non fai che dare noia al baronetto Rossi. Uno di questi giorni il barone mi farà qualche osservazione per causa tua!
Pareva che don Lucio riempisse tutta la stanza con la sua lunga persona.
— Non vi avevo sentito – si scusò Nicolina. – Anche Antonietta non vi ha sentito… credo… È di là.
— Fate pure il vostro comodo! Ormai il padrone di casa non conta più del gatto. Entra, esce, va, torna, e nessuno se ne avvede. I signorini si debbono divertire.
Alessio riunì a fascio libri e rassegne e uscì, a capo chino.
Nicolina mise a posto cappello bastone pastrano di don Lucio. Gli portò le pantofole.
— Volete altro?
— Niente altro – rispose con voce rabbonita don Lucio. Passandole un braccio intorno alla vita si piegò un poco e le disse piano, coll’alito che sapeva di pipa sulla faccia:
— Tu dài troppa confidenza a tuo nipote.
E siccome Nicolina lo guardò un po’ sorpresa, spiegò:
— È un’età pericolosa, quella. E tu sei giovane ancora.
E lo sguardo, torbido di desiderio cattivo, fu più eloquente delle brevi parole.
Nicolina si sentì una vampata di sangue al viso. Liberandosi dalla stretta del braccio nervigno, quasi fuggì. Non mai le carezze del cognato – del padre di Alessio – le avevano dato un senso di ribrezzo così profondo. Fuggì via, fece di corsa la scaletta, s’accasciò sull’ultimo scalino, con la faccia tra le mani.
— Dio! Dio! – mormorò. – È veramente così pieno di male, il mondo?
Sì, il male è dappertutto e non ce ne avvediamo e non ce ne possiamo guardare. Il male è un mostruoso polipo tentacolare…
— Zia Nicolina! – esclamò Alessio. – Ti ha sgridata per causa mia?
— No, no. Tu non c’entri! – esclamò Nicolina vivacemente, asciugandosi gli occhi. Guardò il nipote e sorrise con amarezza. Il gracile viso aveva una espressione di pietà così dolce e femminea, così soave, così triste, come l’angelo di Melozzo che avevano guardato assieme in un’ora di alto e fugace godimento.
No. No. Lui, lui solo, poteva scorgere il male dappertutto, perché il male era nel suo spirito.
Strinse fra le mani la testa del fanciullo e lo baciò sulla fronte, teneramente, come se fosse un pochino mamma anche lei, sì anche lei che uno dei viscidi tentacoli del male aveva per sempre afferrata.
Le orecchie le ronzavano. Qualcuno ripeteva (era Antonietta? era la voce dell’anima sua?), qualcuno ripeteva: – Tu non dovevi rimanere qui…
Il rimprovero – muto e giusto – le si era maturato dentro, inconsapevolmente…
Ebbene, bisognava avere il coraggio di riparare.
Alessio non ascoltava le ultime istruzioni di mastro Ciàula, che gli affidava una delle più fragili biciclette per cinquanta centesimi ogni mezz’ora.
L’inforcò e via. Via per le strade trafficate e finalmente all’aperto, lungo il mare, senza ripigliare il fiato. Via sfrenatamente lungo la riva tranquilla passando borghi e casali. Via senza pensare al ritorno, felice di correre così, senza mèta, senza scopo, mentre il vento gli sbatteva sulla faccia l’afrore della salsedine.
Dall’orizzonte si staccavano nubi piene di rosea luce. Uno stormo di candidi gabbiani volava sul mare.
A quell’ora la casa nel vicolo restava ancora in ombra; le donne, le sorelle nemiche, erano già intente alle solite occupazioni domestiche, col pensiero fisso nello stesso rancore come una manìa.
Il sole, il forte sole vivificatore, giungeva tardi nei balconi della monotona triste opprimente casa che guardava il vicolo…
Fuori si respirava con gioiosa libertà, a pieni polmoni; anche la mente sembrava aprirsi a più larghi e più audaci pensieri… E un giorno sarebbe fuggito così, fuggito per sempre, senza voltarsi, abbandonando ogni cosa, rinnovandosi tutto, come una pianta che si rinnova a primavera.
Piegato sulla macchina aveva l’illusione di volare. Fuso in un pezzo solo con la macchina, ali e non pedali egli possedeva! Era forse, improvvisamente, diventato un gabbiano? o una di quelle favolose creature della mitologia – uomini alati?
La bicicletta fece uno scossone. Qualche cosa si contorse, si spezzò. Alessio si sentì gettare di fianco violentemente.
Una donna accorse. Egli cercava di rialzarsi, vergognandosi di essere caduto e temendo di aver sciupato la macchina non sua. Alcuni pescatori che rassettavano reti sulla sabbia, un operaio che passava, si avvicinarono.
— Non s’è accorto del fosso…
— Aveva pigliato una corsa, una corsa! … – Io gli volevo gridare!
Alessio non poteva camminare: gli doleva una gamba; sedette avvilito.
— È fatta, signorino – disse l’operaio esaminando la bicicletta. – Il guasto è serio. Ci vuole il pezzo nuovo. Ma guardate! San Giorgio benedetto! – esclamò, osservando meglio. – Era saldato proprio qui, vede? Proprio su questo punto! E correva così! Non lo sapeva?
— È una bicicletta a nolo – confessò Alessio, guardando.
Si vedeva una vecchia saldatura nel punto spezzato. Ciò lo rianimò un poco. Mastro Ciàula non poteva pretendere di essere pagato.
Riprese a piedi la via, mogio mogio perché la gamba continuava a dolergli. Esausto si ripresentò a mastro Ciàula che per prima cosa disse:
— Due ore e non mezz’ora. Son due lire.
Osservando il guasto si fece una faccia scura come mezzanotte. Alle giustificazioni di Alessio rispose gridando e buttando per terra la berretta.
— Frodato! Frodato! – ripeteva sghignazzando. – Chi t’ha frodato? Il malanno che ti colga! La macchina era perfetta. No? E perché non l’hai guardata prima? Mastro Ciàula non inganna nessuno. È un galantuomo. Domanda a chi vuoi. Se la macchina la montava uno di giudizio sarebbe intatta, a quest’ora…
Poi si calmò e rimettendosi la berretta in capo disse con tono sicuro:
— L’aggiustatura costa cinquanta lire: ci vuole tutto il pezzo nuovo. E due lire di noleggio fanno cinquantadue. Me le porti domani stesso. Aspetto anche fino a doman l’altro. Dillo a papà. Non sei il figlio di don Lucio Carmine? Lui soldi da pagare ne ha. Altro se ne ha! Un figlio come te ci voleva come il pane per don Lucio Carmine!
Alessio si sentì agghiacciare il sangue. Riprese la via accasciato, con la testa affondata in mezzo alle spalle.
Guardata dall’esterno la casa, più grande più scura del solito, gli fece quasi paura.
— Di dove torni così tardi? Non sei stato a scuola? Che ti sei fatto? Tutto infangato! Tutto impolverato!
— Niente. Taci. Sono caduto. È tornato papà?
— Non ancora.
S’affrettò a salire la scaletta. Salendo udì la voce di Nicolina che diceva forte:
— Nessuno. È tornato Alessio.
Gli parve che Nicolina avesse una voce nuova, o almeno diversa dal solito. Diceva una cosa semplice e giusta, alla quale non aveva mai pensato. Nessuno… Egli era «nessuno»… Senza sapere perché, la sua pena si accrebbe.
Aspettò che il padre si mettesse a fumare la pipa, dopo la sostanziosa colazione, ché allora non si moveva anche se crollasse la casa.
Confidò alla madre l’impiccio in cui si trovava.
— Bisogna saperglielo dire – concluse. – Lei saprà farlo meglio. A me non mi ascolterebbe. È necessario che prima di pagare, tenti lui di far valere le mie ragioni. È un ricatto. Mastro Ciàula si profitta perché sono un ragazzo. Papà può mettere le cose a posto.
Antonietta si allarmò. Cinquanta lire! Cinquanta lire!
— Del resto – aggiunse Alessio, e un’ombra gli passò sul volto – non casca il mondo, capisce? Alla fin fine si tratta di dimostrare a quell’uomo che non sono un orfano e che mio padre, all’occorrenza, si interessa di me facendo valere le mie ragioni. Perché la ragione sta dalla mia.
Antonietta restò un attimo perplessa. Finalmente, per amore di suo figlio, si fece animo.
— Aspetta – mormorò.
Entrò nella stanza da pranzo, indugiò un momento. Rinchiuse l’uscio. Si avvicinò alla tavola.
— Lucio – disse finalmente. – Ti debbo parlare.
Don Lucio alzò gli occhi, corrugandosi. Certo si trattava della vecchia di Sant’Agata… Cominciava a esserne stufo.
— Alessio – principiò Antonietta – ieri è andato in bicicletta. A nolo s’intende. Per muoversi un poco. È caduto. Si è fatto male. La bicicletta si è guastata un poco. Anzi molto. Si è guastata – ripeté senza nascondere il proprio imbarazzo, non sapendo come continuare. – Si è rotto un pezzo importante della macchina, non so come si chiama.
Alessio ascoltava avvilito. Era forse necessario tutto quel preambolo? Così malamente avrebbe saputo parlare anche lui! Ma una moglie non è un figlio e qualche parola più netta, più brusca, se la può permettere! Avrebbe dovuto spiegare la cosa in poche frasi. Era così evidente che la ragione stava dalla sua! Il denaro veniva in secondo luogo.
Il tono di voce sommesso, quasi lamentoso, di sua madre, gli lacerava l’anima.
«Oh! – si domandò esasperato. – Perché siamo tutti senza coraggio, in questa casa?».
— L’avevano ingannato, povero figlio. Ora ha riportato la bicicletta e ci vogliono cinquanta lire – disse finalmente, d’un fiato, Antonietta.
— E io che c’entro in questi pasticci? – fece don Lucio con la sua flemma che certe volte era più crudele d’una staffilata.
— Dio mio! – mormorò Antonietta torcendosi le mani gelate sotto il grembiule nero. – È chiaro che si raccomanda a te. A chi altri deve ricorrere quel povero figlio?
— A me? Comincia presto a sprecare, il signorino. Cinquanta lire! Cinquanta lire – ripeté calmo calmo, posando la pipa sul vassoio di rame, – non si vanno a scavare nell’orto. Io non ho quattrini per pagare i suoi capricci. Io lavoro. Cento volte gli ho proibito di prendere biciclette a nolo.
— E allora? Che gli rispondo a quella creatura che aspetta come un’anima del purgatorio?
Nicolina, in cucina, ascoltava col respiro sospeso. Era stata lì lì per entrare, per aiutare Antonietta. Ma era rimasta immobile nel timore di far peggio.
— Digli – rispose don Lucio, guardando finalmente in faccia la moglie che tremava come avesse la terzana, – digli che impari a ubbidire. E tu non mi stare più davanti come una disperata. Tuo figlio non fa che darmi bocconi amari.
Antonietta uscì dalla stanza. Nicolina, presso i fornelli, piangeva silenziosamente.
La madre disse al figlio, piano ché non sentisse don Lucio:
— Senti. Non le ha sul momento. Ma non ti affliggere. Vedrai, per le quattro io e… tua zia, troveremo il denaro. Non è poi una gran somma.
— Ho sentito – fece Alessio con un sorriso che strinse il cuore alla madre, tanto era desolato. – Non è giusto che cominciate ad angustiarvi «anche» per causa mia. Mi confiderò con Ferdinando, sai, il mio compagno ricco. Glielo renderemo a poco per volta. Papà non ne saprà nulla. Sul Rossi posso contare. È come un fratello.
— Sì, faremo così – esclamò Antonietta rinfrancata. – È una pensata veramente buona, Alessio. Ma dove vai a quest’ora? Avevi detto che oggi è vacanza.
— Ho guardato l’orario. Ho un’ora di matematica… Dopo andrò da Ferdinando Rossi… Senta – aggiunse abbracciandola e nascondendosi il viso sulla spalla materna. – Mi perdoni se le ho dato questo soprassalto. E abbia coraggio. Abbia coraggio, mamma. La vita è una cosa triste. Anche, la prego, perdoni alla zia. Ha sofferto la sua parte… E ora basta – e volle sorridere per non dare soverchia gravità alle parole che gli nascevano spontanee dal profondo dell’anima. Era la prima volta che osava accennare a «quel fatto». La madre trasalì.
— Tu piangi? – esclamò scostandosi per guardarlo in faccia.
— Sono un po’ strano, stamattina – fece Alessio sorridendo di nuovo, col mento che gli tremava un poco. – Mi benedica, mamma.
— Santo e benedetto, figlio mio.
Alessio schiuse l’uscio adagio adagio. Don Lucio si faceva pettinare; con la testa arrovesciata sulla spalliera pareva sonnecchiasse. Nicolina lo pettinava lentamente. Aveva gli occhi rossi.
Sempre, sempre così uguali e pesanti scorrevan le ore nella casa del vicolo.
Alessio salutò con un cenno della mano Nicolina e sparì di corsa nelle scale umide e scure.
Don Lucio, di già a tavola, fece tintinnare la posata contro la bottiglia, in segno d’impazienza. Allora Antonietta afferrò con le due mani la zuppiera, da un pezzo pronta, e Nicolina riscalducchiò la scodella del cognato perché la minestra non perdesse il suo calore.
Alessio avrebbe dato molto filo da torcere! E dire che era ancora un ragazzo! Dopo l’incidente della mattina era uscito e chi s’è visto s’è visto. Dov’era andato? Dove si tratteneva a quell’ora?
«E se il suo amico si rifiuta di aiutarlo?». Pensò Antonietta avviandosi con la zuppiera.
— Da quanto tempo è uscito? – domandò dopo un silenzio don Lucio mentre Antonietta scodellava e le bambine si facevano la croce frettolosamente.
Nessuno rispose. Come don Lucio ripeté la sua oziosa domanda, Antonietta mormorò:
— Da stamattina. Tu lo sai.
Don Lucio cominciò a mangiare. Il silenzio gravò come una nebbia nella stanza. Le bambine raccoglievano le ultime cucchiaiate di minestra, cercando di non fare rumore. Anche Antonietta era impaziente di finire, di alzarsi, di andare alla finestra per aspettare Alessio.
Solo don Lucio non perdeva la calma: con le spalle bene appoggiate contro la spalliera della poltrona di cuoio, gli occhi socchiusi masticava adagio adagio, assaporando il cibo.
Finalmente le bambine si poterono, alzare. Antonietta sparecchiò. Nicolina portò sulla tavola la macchinetta e tutto l’occorrente, ché don Lucio voleva vederlo preparare, il caffè, e sentirne tutto l’aroma. Nicolina si mostrava tranquilla nel compiere il suo dovere con la consueta precisione. Ecco che macinava, buttava un cucchiaio di caffè nel bricco fumante, copriva, rimestava appena si levava il bollore, tornava a coprire e finalmente spegneva la fiamma senza che una goccia d’acqua si fosse versata o un po’ della nera schiuma del caffè avesse imbrattato il bricco pulito, lucente, che pareva d’argento.
Ma anche lei, come Antonietta, era tormentata dall’apprensione.
No, non era mai successo che Alessio tardasse tanto a tornare!
Don Lucio centellinava il suo caffè voluttuosamente. Sazio, ben sodisfatto, non desiderava nulla, in quel momento, e in cuor suo aveva del tutto dimenticato l’assenza del figlio e non si avvedeva dell’ansietà che faceva impallidire i due volti.
Picchiavano. Un picchio discreto, quasi timido. Era Alessio, senza dubbio. Sarebbe entrato, al solito, un po’ eccitato, un po’ trepidante…
Carmelina corse ad aprire.
— Papà. C’è uno, di là, che la vuole.
— A quest’ora! – sbuffò don Lucio. – Digli… No. Torna qui – si corresse subito, posando la chicchera, contrariato, rammentandosi di un debitore che gli voleva parlare.
Le donne ascoltarono. Udirono un bisbiglio confuso, interrotto, poi chiudersi la porta e aprirsi l’uscio della camera. Don Lucio chiamò: — Antonietta!
Accorsero tutte e due.
— Debbo uscire.
L’aiutarono a infilarsi il cappotto; poi gli vollero accomodare la cravatta; ma don Lucio aveva fretta.
— Non serve… Non serve… – disse. La sua voce era alterata come non mai. Turbato, cercava qualche cosa senza voler dire che gli bisognasse, e le mani gli tremavano. Antonietta si fece animo e tornò, non veduta, nella saletta.
Era successo qualche cosa che riguardava anche lei. Lo sentiva.
L’uomo stava ancora in mezzo alla porta chiusa, a testa bassa, col berretto fra le mani – un berretto gallonato.
Antonietta «sentì» che era un servo del barone Rossi. Gli disse piano, in fretta:
— Per l’amore di Dio, ditemi che è successo, se è una cosa… – voleva dire «se è una cosa che riguarda me stessa» ma le mancava il respiro per l’ansietà, perché pensava ad Alessio, soltanto ad Alessio.
Il servo credette, a vederla così sconvolta, che sapesse. Rispose:
— Non si spaventi. Non è cosa grave.
Antonietta lo fissò, con gli occhi grandi, dilatati.
— Chi non è grave? Parlate chiaro. Mio figlio non è rientrato, da stamattina. Abbiate pietà d’una mamma. Parlate. Dov’è?
Il servo la guardò a sua volta perplesso, non sapendo come regolarsi, perché gli ordini che gli avevano dato erano precisi. Ma ebbe compassione di quella povera signora che aspettava una sua parola, tutta sconvolta, e mentre don Lucio veniva dalla camera, imbacuccato nella sciarpa di lana per non risentirsi del freddo della notte, mormorò:
— Sono di casa Rossi, come vede. Si faccia coraggio, signora…
Antonietta sentì un dolore acutissimo, lancinante, come se le avessero strappato lo stomaco.
— Lucio! Lucio! – gridò correndo dietro al marito.
Il marito si voltò bruscamente e le fece segno di tacere e di chiudersi dentro casa.
— Torno subito – rispose forte. E continuò a scendere le scale.
Antonietta rimase sul pianerottolo come pietrificata.
— Chi è? Che è successo? – ripeté Nicolina.
— È il servo del barone Rossi. La Madonna ci ha castigate.
E s’accasciò sul pianerottolo come un fagotto di cenci. Nicolina si cacciò le mani tra i capelli.
— Alessio! Alessiuccio! – mormorò perdutamente. Vedeva girare e ballare gli scalini, come fosse sul vapore, le orecchie le fischiavano.
Restarono un momento in silenzio, l’una e l’altra. Le bambine cominciarono a piangere spaventate nel veder la madre per terra, fuori dell’uscio.
Nicolina trasalì, udendole. Le rimproverò:
— Tacete. Che significa questo pianto di malaugurio? Tacete. Noi non sappiamo nulla.
— Forse non ha il coraggio di rientrare a quest’ora… – aggiunse con voce più bassa, aggrappandosi a una speranza.
Si chinò su Antonietta.
— Alzati – pregò dolcemente.
— No! – esclamò la sorella senza guardarla. – Lasciami aspettare in pace.
Tacquero di nuovo, restando fuori dell’uscio come due povere. E i minuti, che passavano nel silenzio gravato di mistero e di paura, furono eterni.
Nicolina disse finalmente, e pareva che parlasse in sonno:
— È il servo del barone. Antonietta, io so dov’è il palazzo Rossi…
Allora Antonietta si alzò faticosamente dando una mano alla sorella perché l’aiutasse.
— La Madonna ci ha castigate – ripeté.
Il suo sguardo era simile a quello d’un uomo debole e ferito che deve accettare il soccorso dell’odiato nemico.
La folla si stringeva, fitta come una siepe, davanti al portone chiuso del palazzo. Nella piazza passava ancora gente nuova: alcuni si fermavano a domandare; altri tiravano dritto affrettando il passo per non esser chiamati a testimoniare nel caso che fosse avvenuto qualche fattaccio.
Una donna piangeva e tratto tratto ripeteva:
— A quell’età! A quell’età! Signore, tieni le tue mani sul capo de’ miei figli!
Un signore vecchio, dagli occhiali d’oro e dalla lunga barba candida, si fermò anche lui a domandare.
— Era un ragazzo felice – spiegò un ometto piccolo e secco (il notaio Marullo). – Figlio unico, adorato dai parenti… Non gli mancava niente…
— Eh! Eh! – tossicchiò il vecchio signore. – Chi può entrare nella loro mente, egregio notaio! Si può tormentare un fanciullo senza volerlo e senza saperlo. C’è un’età in cui le piccole miserie della vita appaiono terribili. Hanno gli occhi del bove… Se ce ne occupassimo un pochino di più…
Il vecchio si allontanò subito. Un operaio volle dire la sua:
— Parla fiorito quel signore. Ma io senza sapere leggere e scrivere, ne so qualche cosa della vita. Capisco che la colpa è solo dei tempi. Prima queste cose non succedevano. I ragazzi non cercavano l’erba che non è nata… Volevano il pane, il sonno, e temevano solo il padre… Oggi che son vecchi prima di nascere…
Un sussurro corse nella folla. Un uomo lungo e magro, incappottato, attraversava la piazza seguìto da un servo.
— È il padre! – bisbigliarono.
— Quello?
— Sì, quello.
— Ho riconosciuto il servo che è andato a chiamarlo.
— Fammi un po’ di largo. Non lo vedo!
— È il padre…
— È il padre… – bisbigliò ancora la folla stringendosi più fitta dietro il portone che si aprì, per lasciare passare don Lucio, e subito si richiuse pesantemente.
Correva sulla folla, come un brivido, la morbosa curiosità di assistere alla scena che avveniva lassù, nella stanza illuminata.
Il portone fu riaperto e richiuso. Usciva il servo con un biglietto. Lo fermarono. C’era ancora qualcuno che non aveva sentito tutti i particolari.
— Non so niente io – ripeté il servo commosso, non sapendo vincere il bisogno che aveva di sfogare e di raccontare. – Il mio povero padroncino è nel letto, per la scossa avuta. C’è il dottore. Lo stesso dottore che fu chiamato per l’«altro». Corro per una medicina. Ho fretta. Lasciatemi andare. Come fu? E che vi posso dire? Io non so nulla. Il mio padroncino dice che il suo compagno volle provare l’arma, per ischerzo, dopo colazione. Ha detto così alla Giustizia. È la verità. Era rimasto a colazione con noi perché aveva deciso: «Io a casa non ci torno». Il barone gli promise che avrebbe parlato lui, al padre. «Vedrai che passerà!». Lui non voleva. Prima era eccitato. Non sapeva lui stesso che volesse fare. Voleva scappare. Parlava di nascondersi in un vapore. Lo sentii anch’io, che farneticava. Per questo il baronetto se lo volle tenere vicino. Gli voleva bene come fosse stato un pari suo. Pareva che ci fosse riuscito, a calmarlo. Meglio l’avesse lasciato andare libero! A quest’ora, chi sa? Dunque volle provare l’arma. Disse: «Beato te che ci hai persino la rivoltella a portata di mano!». Il mio padroncino si mise a ridere. Poi cominciarono a leggere un libro. Mentre leggevano, il padroncino dovette andare nello studio del nonno, del barone grande. Lasciò solo quell’altro. Qualche volta lo lasciava solo perché, dice, era così educato che non s’arrischiava neanche a guardare nella libreria. Dunque va… Non passa un minuto e si sente un colpo… un altro… Si vede che gli dovette passare per la testa una brutta idea, tutt’a un tratto. Son tempeste. Il nostro pensiero è come il fondo del mare. Se il mio padroncino non lo avesse lasciato solo, con quel revolver a portata di mano… Chi sa! Passato il momento… Dalla stanza si passa direttamente nel giardino. Lui andò in giardino. Cose, vi dico, cose! E a vederlo ora, Signore! Non pare che sia morto di mala morte!… Lasciatemi andare, per carità, ché aspettano la medicina…
Si allontanò, parlando ancora fra sé e sé, gesticolando. La gente cominciò a squagliarsi, ché non c’era più niente da vedere e da sentire.
Nella piazza, mezzo deserta, passarono due donne, chiuse negli scialli neri. Picchiarono, entrarono.
Anche i pochi rimasti si dispersero. Lo spettacolo era finito. Palazzo Rossi, maestoso e cupo, restò isolato, tutto chiuso. Una sola finestra restava aperta, piena delle rosse tremolanti luci delle torce accese.
Durante i tre giorni delle visite, le bambine furono lasciate anche la notte dalle monache. Don Lucio – con la barba lunga, il berrettino cacciato fino alle orecchie, con tutto l’aspetto di un uomo in lutto, – si commoveva dentro di se stesso dandosi una sbirciata nello specchio, e si andava a frullare qualche uovo in cucina, nei momenti di libertà, perché gli pareva che i battiti del polso fossero un po’ fiochi.
Per tre giorni fu una processione di gente. Don Lucio aveva molti amici e conoscenti: soci dei circoli e delle leghe di cui faceva parte, gente che dipendeva dal barone; e, più che altro, debitori.
Chi veniva per dovere, chi per la speranza di ingraziarsi con lui, chi per curiosità, chi per il gusto di poter finalmente mettere piede nella casa di uno che, senza esser misantropo, non aveva mai voluto aprire la sua porta ad alcuno.
Tante visite rasserenavano don Lucio e lo liberavano a poco a poco dall’assillante timore che la morte violenta di Alessio potesse adombrare la buona fama che s’era fatta in città. Proprio in quei giorni il barone gli aveva promesso di affidare a lui, a lui solo, tutta l’amministrazione dei beni, e l’assessore Laurà gli aveva fatto balenare la speranza di un incarico di fiducia al Municipio… Tutti lo stimavano, lo apprezzavano, lo adulavano… Ma i nemici, che aspettavano, nell’ombra, per colpirlo alla schiena, non si sarebbero giovati del tragico avvenimento per attirare l’attenzione sulla sua vita privata, per discreditarlo presso il barone, e presso tutti coloro che gli avevano fiducia?
Questi pensieri erano tormentosi.
Ma i suoi timori si dileguavano adagio adagio. Il fanciullo non aveva lasciato un segno che spiegasse la spaventosa risoluzione – che forse gli era venuta all’improvviso come un attacco di follìa. Non aveva scritto una parola. I suoi quaderni, i suoi libri, lasciati in ordine sul tavolino a piedi del letto di Nicolina, non contenevano alcun ricordo. Se n’era andato così, senza lasciare traccia di sé…
I visitatori entravano senza salutare nel salottino in penombra, sedevano in silenzio, come è l’uso.
— Un colpo… Un forte colpo… Animo, povero amico…
Sottovoce tessevano le sue lodi, ripetendo che un uomo come lui, dedicato alla famiglia come lui, non meritava una sventura così tremenda. Don Lucio, sprofondato in una poltrona, col mento sul petto, pareva non ascoltare, come è l’uso.
C’era anche un articolo sullo «Scilla e Cariddi». Qualcuno lo passava a don Lucio, misteriosamente.
— Quando sarà più calmo. È lavoro di un professore di liceo. È scritto con molto acume.
A voce bassa riassumevano il contenuto dell’articolo in cui si parlava della decadenza dei tempi, e delle squilibranti letture seguìte dai giovani. Don Lucio prendeva il giornale senza aprire bocca e lo posava sul tavolino che s’era messo a lato e su cui erano radunate le condoglianze: i biglietti dei conoscenti, un telegramma delle sue sorelle maritate, di Catania, una lettera da Sant’Agata, e poi, più in vista, un biglietto scritto di pugno del barone e una busta, col timbro del Municipio, dell’assessore Laurà. Era bene che i nemici, se ve ne erano tra i visitatori, vedessero che don Lucio Carmine era sempre, anche nella sventura, un uomo di qualche importanza…
Ascoltava con interesse i vari commenti, i racconti, le brevi parole, che gli davano un’idea dell’impressione destata in città. Il triste avvenimento era considerato da tutti allo stesso modo. Pareva si fossero data la voce.
Alessio era giudicato con indulgenza, come un ragazzo guastato dalle cattive letture. Il giudizio generale e il magnifico articolo psicologico dello «Scilla e Cariddi» erano avvalorati dal fatto che si era trovato aperto sul tavolino, a cui erano seduti i due compagni, un libro intitolato: «La vita è una sciocchezza».
Le donne, rifugiate nella stanza da pranzo, non ricevevano visite. Esse non conoscevano nessuno. Qualche vicina del vicolo e la vedova del primo piano salirono per compassione delle due povere signore «sole come anime in pena».
Una delle tre sere venne anche la moglie d’un impiegato che s’era fatto prestare una forte somma da don Lucio. L’impiegato aveva pensato di condurre la moglie, sperando che l’omaggio gli facesse perdonare un acconto non dato…
Era una signora mal vestita, che portava una logora mantiglia di seta arrossata dal tempo. Finché durò la sua visita – aspettava che il marito, dal salottino, venisse a chiamarla, – tacque sempre, tenendo le mani conserte e gli occhi a terra: povere mani che s’indovinavano, deformate e nodose, dentro i grossi guanti di cotone; occhi stanchi, dalle palpebre un po’ arrossate. La sua presenza portò una specie di conforto nella stanza piena d’ombre. Non parlava. Ma pareva dicesse piano, con la sua umile e rassegnata attitudine di signora povera:
«È la nostra vita. Che farci? È così. Lavorare, allevare i nostri figli con dolore. Noi diamo alle nostre creature il latte, e qualche lacrima che sfugge dalle nostre ciglia. È quella lacrima, succhiata col latte, che avvelena per sempre la loro vita…».
E le donne, assorte, crollando un po’ la testa, pareva approvassero le parole non dette.
Un momento prima di andarsene, la moglie dell’impiegato povero disse, quasi che ripigliasse un discorso interrotto:
— …aveva quindici anni, mia figlia, quando scappò di casa. Ora abbiamo fatto la pace. Ma suo marito la batte e lei lavora per mantenerlo. Tante notti sentiamo picchiare. Apro. È lei che viene a cercare rifugio in casa nostra. Per questo non basta la pensione di mio marito… Ebbene, non sarebbe stato meglio piangerla una volta sola, anziché vederle trascinare il peso della sua brutta sorte?…
Tacque asciugandosi gli occhi. Voleva dire che, certe volte, la morte è più saggia della vita.
Le due sorelle la guardarono un momento. Il silenzio tornò a colmare la stanza.
Antonietta non aveva pianto una volta. I suoi occhi erano rimasti asciutti anche entrando nella casa estranea dove c’era Alessio; ora gli occhi le bruciavano come se le lacrime che non aveva versate, fossero tutte raggrumate fra le ciglia.
Nicolina era stanca, snervata. Due volte aveva perduto i sensi. Ora sbadigliava, con la testa pesante. Le giungeva il monotono sussurrìo del salottino. Il tempo passava lentissimamente. Soffriva, come se aspettasse una liberazione che non veniva mai, e guardava di tanto in tanto la sorella, implorando.
Ma Antonietta restava immobile, rannicchiata nell’ombra. La sua faccia, che usciva dallo scialle nero, come da una cupa cornice ovale, aveva riflessi giallognoli. Guardava davanti a sé, senza batter palpebra. Nicolina aveva paura di quella faccia senza espressione. Nell’oscurità, fra le molli pieghe dello scialle nero, quel volto pareva mostrarsi, senza corpo, come l’apparizione di un fantasma. Accendeva il lume per vedersi dinanzi la sorella, e non più quel volto sospeso.
Antonietta si alzava. Non voleva la luce. Si raggomitolava nel cantuccio più lontano, e riprendeva la sua immobilità.
E Nicolina vedeva sorgere di nuovo, dall’ombra, quel volto simile al volto di una donna morta che emerga dall’acqua d’una livida palude.
Si nascondeva gli occhi con le mani, esasperata. Con gli occhi chiusi rivedeva il nipote morto, sul lettino del compagno ricco, fra due grandi torce accese e fumicose. Piangeva allora di terrore, adagio adagio, come una bambina che non trova scampo, inseguita dalla propria ombra.
Dio! Dio mio! Sarà sempre così? Così? Sempre?
E gemeva e singhiozzava forte per rompere il silenzio della stanza, sperando che anche Antonietta si sfogasse a piangere.
Ma Antonietta restava impassibile.
Nicolina preparò l’acqua col limone. Portò la cartella sul tavolino. Si guardò intorno per vedere se ogni cosa fosse a posto, se non fosse mancato nulla al cognato, quando tornava. Ora lui, dopo cena, andava a far due passi. Forse parevan lunghe anche a lui le serate.
Si fermò davanti all’uscio chiuso della camera.
— Buona sera, Antonietta. Vado a letto – le gridò. Aspettò un momento la risposta, attraverso l’uscio. Salì la scaletta di legno, sollevata dalla certezza che per quella sera non si sarebbe dovuta incontrare col cognato. Essa era sempre la Nicolina umile e obbediente. Ma essa ora lo sfuggiva.
— Lasciatemi – osava pregare con la voce arrochita, allorché egli le afferrava i due polsi, attirandosela sul petto. – Lasciatemi…
Egli la lasciava andare e corrugando la fronte la guardava uscire dalla stanza, gracile, sottile, con le spalle un po’ piene e il petto incavato, i fianchi appena accennati sotto l’ampia gonna di cotonina nera. Anche lui, in un attimo, rivedeva Alessio sul lettino estraneo, calmo come se si fosse addormentato senza volerlo, nella casa estranea. Si levava gli occhiali e, sprofondato nella poltrona di cuoio, cominciava a fumare per non vedere. Ma non sempre riusciva a cancellare la penosa visione. Usciva. Cercava d’incontrare qualche amico, che lo invitasse a entrare in un caffè, a teatro, o che almeno lo costringesse a fare un pezzo di strada assieme discorrendo.
Aveva pur diritto di vivere in pace. Non aveva fatto male ad alcuno. Il destino delle cose non era in mano sua. Certo, se fosse stato in suo potere, egli avrebbe fatto felice suo figlio.
Ma di che cosa aveva sofferto, quel ragazzo? L’aveva forse maltrattato, lui? Era forse stato un padre tiranno, lui, un padre disamorato?
La sua propria fanciullezza, sì, era stata dura ed aspra! Era cresciuto col nonno, un vecchio forte e bizzoso, che l’aveva picchiato senza pietà, e poi l’aveva scacciato di casa… Ebbene egli aveva trovato in se stesso i mezzi e le forze di aprirsi una via. Anche le sorelle, povere ma rassegnate e prudenti, avevano trovato la loro via.
L’altro – suo figlio – era un debole.
Un rifiuto (e don Lucio trasaliva al ricordo come se qualcuno dentro la sua stessa anima lo accusasse), un rifiuto fatto recisamente, a fin di bene, era bastato a sconvolgergli il cervello – a fargli pesare la vita.
Era un debole. Presto sarebbe stato un vinto. Non era sua colpa, no, se non aveva saputo trasmettergli intera l’energica volontà di vivere.
Riflettendo così, cercando di suggestionarsi, ricuperava il dominio di se stesso.
Allora, se il ribrezzo delle sue speculazioni lo coglieva – pensando all’incidente della collana d’oro, – diventava più aspro verso i suoi debitori e non si curava di far misteri in casa.
— Sì – diceva a Nicolina che guardava spaventata i bei gioielli della cassetta di ebano. – Sì, io impiego così il mio denaro. Le ragazze saranno ricche, domani. Lo faccio per loro. Ma non fare la stupida anche tu! Credi che io sia uomo da rovinare la gente? Ho una faccia da strozzino, io? È un commercio come un altro…
No. Non poteva tollerare che il ricordo di Alessio, l’impressione di quella sera di Natale, soprattutto il falso sentimento di decoro fin allora alimentato, dovessero paralizzare la sua volontà.
E cercava tutte le occasioni per incutere timore alle figlie, pallide, magroline, vestite di nero, lunghe lunghe… Non le mandava più neanche dalle monache, perché non gli sfuggissero, come Alessio. Le voleva custodire. Le voleva formare lui, a suo modo, docili, semplici, ignoranti, senza desideri, come debbono essere le donne.
Qualche sera, mentre le bambine andavano a letto e Nicolina girava ancora per casa, egli la chiamava. L’abbracciava, baciandola sulla nuca con violenza, quasi con collera, per stabilire, ancora una volta, ch’era lui il padrone. Essa ripeteva, sbiancata e riluttante:
— Lasciatemi…
E trovava la forza di difendersi, per sfuggirgli. Non le badava. Si divertiva a vincere lui, a mostrarsi il più forte. La conduceva, tenendola stretta nel salottino – dove ora dormiva solo –, con un sorriso cattivo sotto i baffi a spazzola.
Sentiva tremare Nicolina tra le sue braccia nervigne. Ma non voleva badarle.
Quelle notti, mentre il cognato dormiva russando, Nicolina vegliava. Seduta a piedi del lettino intatto, davanti al tavolino su cui custodiva in ordine i libri di Alessio, vegliava pregando. E pregava, e domandava perdono anche per suo cognato.
La vita era mutata per tutti irrimediabilmente, mentre pareva la stessa. Anche don Lucio se ne rendeva conto. La cognata continuava a servirlo con la stessa precisione, ma il viso pallido e dolente aveva l’espressione rassegnata di chi adempie un obbligo increscioso. Antonietta non lasciava la propria camera se non chiamata. Essa guardava ostinatamente don Lucio, come se volesse parlargli e non osasse. La sua presenza, muta e dolorosa, irritava forte don Lucio, che finì col consigliare che non la chiamassero più, all’ora dei pasti…
— …Si vede che preferisce di restare sola… – concluse per giustificare il suo consiglio dato con tono così brusco che pareva un comando.
Le bambine apparecchiavano una piccola tavola in camera e le portavano i pasti. Antonietta, che s’era fatto un bizzarro altarino accanto al letto, ringraziò il Signore, nelle sue preghiere, lieta che il marito la lasciasse finalmente in pace nel suo piccolo rifugio. Non si curava di nulla, non si interessava di nulla. Solo le figlie richiamavano ancora la sua attenzione.
— Vi vuol bene, zia Nicolina? – domandava loro. – Siete contente? Signore, vi ringrazio. Io, vedete, non posso fare niente per voi. La Madonna sarà la vostra mammina e vi proteggerà. Così le avessi raccomandato Alessiuccio! Perché, vedete, noi non possiamo prevedere il bene o impedire il male…
Mangiava pochissimo. Non si svestiva più per coricarsi, ma sonnecchiava davanti all’altarino per qualche ora. Il suo sguardo diventava fisso come il suo pensiero.
Si istupidiva.
Col tempo don Lucio si impensierì delle condizioni di Antonietta. Era necessario che mutassero sistema, per qualche tempo. Egli era disposto a sacrificarsi, abbandonando tutte le sue abitudini, buttando via del denaro, purché finalmente la vita potesse ricominciare come prima, rinnovata, liberata dalla nebbia che gravava su tutti. Il denaro serve per il benessere della nostra esistenza! Egli non era un avaro che accumula per il gusto di possedere monete su monete. Non aveva mai guardato a spese per circondarsi di comodi e per rendersi piacevoli i giorni.
Decise di parlare a Nicolina, perché essa gli pareva più ragionevole della sorella e perché non gli piaceva di parlare della cosa alla moglie, direttamente. Da quella sera in cui si erano trovati faccia a faccia in una camera di palazzo Rossi, non si erano più trattenuti assieme.
— Siedi lì – fece gravemente. E cominciò ad accendere la pipa con lentezza, mentre la cognata aspettava, tenendo le mani in grembo, con la sua attitudine umile e accasciata.
— Ho pensato una cosa molto giusta – disse finalmente dopo aver mandato fuori delle boccate di fumo. – Ti sei sciupata. Ti farebbe benone cambiare aria.
E siccome Nicolina sembrava non comprendere e non compiacersi dell’interessamento, aggiunse:
— Tu non vai a Sant’Agata da sei anni. Tua madre è vecchia. Io ti do il permesso e i mezzi.
Nicolina alzò gli occhi fino a lui.
— No – rispose. – Io non me ne vado.
Don Lucio credette d’intendere i rapidi pensieri della cognata e spiegò con insolita pacatezza nella voce:
— Non tu sola. Anche Antonietta. Anche le bambine. Vi svagherete tutte.
Nicolina abbassò il capo. Gli occhi le si riempirono di cocenti lacrime, al timore di doversene andare (era questo il pensiero del cognato?…), di doversene andare, forse per sempre. Essa non amava la casa – oh! no! – ma i dolorosi aspri ricordi che la popolavano, che facevano parte del suo passato, della sua stessa vita.
Doversene andare, ora che non c’era più nulla da riparare…
«Meglio uccidermi, come lui…» pensò. Ma pensò anche ad Antonietta, e un amaro conforto la rianimò:
— Antonietta non vorrà – concluse, alzandosi poiché non aveva altro da aggiungere.
Don Lucio la guardò sorpreso. Fumò la pipa e poi si diresse nella camera della moglie, risolutamente.
Era necessario.
Antonietta lavorava la calza, dietro la finestra. Udendo entrare il marito posò il lavoro e aspettò tranquilla. Don Lucio sedette e disse alla moglie quel che aveva detto alla cognata, con le stesse parole.
— Perché vuoi scacciarmi? – domandò Antonietta dolcemente.
Don Lucio finse di adirarsi. Gridò che lui pensava al bene degli altri e non raccoglieva che ingratitudine. Sapeva che avrebbe ottenuto assai di più con le brusche che con le buone.
— Non capisci che questa vita è insopportabile? Io l’ho ben fatto capire a Nicolina. Ma anche lei è ostinata a restare.
Antonietta sospirò, sollevata. Anche sua sorella, la sua nemica, le dava ragione. Ecco che si trovavano d’accordo, ancora una volta, senza parlarsi. Il legame che le univa, per la vita e per la morte, era sempre più tenace del livore che le divideva anche nel pianto…
Ora don Lucio si adirava, senza fingere. Andava su e giù per la camera e sfogava forte ciò che aveva invano cercato di sopire, per paura d’ammalarsi.
— No – ripeteva con voce roca – …il vostro atteggiamento di accusatrici non mi spaventa. È colpa mia? Rispondi! Liberami da questo peso. Mi accusate davvero? Io non ho colpa. Io ho fatto il mio dovere. Io non ho fatto nulla, proprio nulla per farlo soffrire, ma egli era un debole…
La sua ira smorì lentamente, nelle ultime parole che risonarono come singhiozzi nella camera.
Antonietta lo ascoltava, senza spaventarsi. Egli non poteva più farle del male…
Poi disse, e la sua voce era quieta:
— Ebbene, di che ti angustii? La colpa non è stata tua e non è stata mia. Neanche mia. Se io avessi capito ch’egli soffriva, di tutto… Perché ora lo capisco. Ricordo tante cose, che mi tornano chiare alla memoria, come altrettante spiegazioni. Egli si doleva del dissidio che era nella nostra casa. Tutti un poco gli abbiamo avvelenato la vita, come si avvelena una fresca sorgente. Se io avessi capito, me ne sarei andata con lui. Il mondo è grande. Avrei trovato un rifugio per noi due, per fargli scordare il male che aveva intraveduto. Ma non l’ho mai capito. Ora è troppo tardi, per andarmene. Ora che lui non c’è più. Senza volerlo l’abbiamo ucciso noi, eppure ognuno di noi crede di non avere colpa… Non ti adirare, Lucio. Vedi, ognuno di noi porta il peso della propria sorte sulle spalle. Egli era troppo gracile, per camminare sino alla fine col suo peso. Sì! – ripeté, come se parlasse in sogno, – tutti l’abbiamo ucciso un poco, senza volerlo. Non ti adirare. È così. Una volta, a casa, avevo un cardellino. Era assai domestico. Saltellava per le stanze, e si posava sulla mia spalla. Un, giorno aprii una porta, perché mi chiamavano. L’uccellino restò schiacciato. La colpa non era di chi mi chiamava, né di me che aprivo. Potevamo sempre rammentarci di avere in casa il minuscolo uccello? È così. Noi abbiamo dimenticato, tutti, che c’era una creatura che capiva e soffriva. Non ti adirare, Lucio. È inutile.
Ma don Lucio non si adirava più. Era turbato da quel tono di voce troppo calmo. Essa ragionava quietamente come se discorresse d’una cosa affatto estranea. Così aveva udito parlare un pazzo, una volta. Nel volto pallido e floscio, gli occhi ardevano dilatati, senza espressione.
Disse con dolcezza, come se parlasse a una bambina malata:
— Vogliamo fare una cosa? Vogliamo mandare Nicolina a Sant’Agata, per un po’ di tempo?
La moglie lo guardò, turbata a sua volta.
— No – pregò. – Alessio non vuole. Anche stanotte mi ha detto: «Mamma, non scacciare tua sorella».
— Allora… Ma ascolta! Sii ragionevole! – esclamò don Lucio con tono di comando. – Nicolina partirà con le ragazze. Io… noi… andremo in qualche altro posto. A Catania, dalle mie sorelle. O a Patti, nelle terre del barone. Ti svagherai. Non bado a spese… E la vita – aggiunse quasi timidamente, abbassando la voce – … ricomincerà per tutti.
— Non scacciarmi, Lucio! – pregò Antonietta. – Sei ben cattivo se vuoi impedirmi anche di piangerlo. Io non ti do noia, chiusa qui.
Tacque. E tutta la sua persona prese l’attitudine accasciata di Nicolina.
In quel momento le due sorelle si somigliavano. Anche, pensavano le stesse cose… Pure non si sarebbero mai avvicinate l’una all’altra, non si sarebbero mai scambiata una parola di conforto.
Don Lucio pensò a quando erano a Sant’Agata, giovinette, e si tenevano per mano, vestite dello stesso colore, e lo guardavano con la medesima espressione mansueta e serena di adorazione.
Il molto parlare aveva stancato e sconvolto Antonietta. Levò lo sguardo smarrito.
— Vattene! – disse. – Quando ci siete voialtri, lui non entra… È così bello!… Viene, si ferma accanto a me e mi parla. Vattene, te ne prego…
Sorrise. Quel sorriso ebete sul volto smarrito, spaventò don Lucio che uscì in fretta dalla camera, quasi fuggendo.
Sull’andito si sentì mancare il respiro. Il pavimento gli ballava sotto i piedi. Si appoggiò alla parete.
C’era qualche cosa che sfuggiva al suo volere.
C’era qualcuno (non la moglie, non altri…), qualcuno senza voce, e senza gesti, che lo contrariava per la prima volta.
Ma lui, lui solo, doveva essere il più forte… Entrò nella stanza da pranzo. Sedette al suo solito posto, tenendo le due mani sul petto per sentire i battiti del cuore.
Andare incontro alle emozioni, fare delle discussioni, dopo aver mangiato? Troppo spesso dimenticava di esser malato.
Strinse le labbra, atterrito dall’acuta trafitta al cuore che non lo lasciava più.
Bisognava prender la vita come veniva. Svagarsi, uscire più spesso, esser socievole. È molto igienico scambiar quattro parole, chiacchierare di cose che non interessano, con un conoscente, dopo aver desinato.
Si era fatto socio anche della Humanitas (lega di protezione per le giovanette), gli avevano dato il delicato incarico al Municipio (quello promesso dall’assessore Laurà)… Aveva molte occupazioni fuori di casa. Non poteva ingrullirsi come una femminuccia.
Si alzò e andò a vestirsi per uscire. Nella saletta Nicolina l’aiutò a infilarsi la spolverina e gli spazzolò il bavero. Ma le premure di cui lo circondava la cognata – esile, pallida, vestita di nero – non gli procurarono alcuna sodisfazione.
Scese le scale adagio adagio, profondamente turbato per la trafitta che tornava. Ecco che poteva morire, da un’ora all’altra; uscire di casa per non rientrarvi più.
No, bisognava ricominciare la vita, come prima.
Si avviò lentamente. Per un minuto la sua ombra smisurata si disegnò, oscillante, nel vicolo mal rischiarato.
E la vita ricominciò di nuovo, con le sue giornate uguali. La casa nel vicolo, regolata come un orologio, sembrò piena di pace, come prima. Ognuno riprese le vecchie abitudini che si seguono meccanicamente, come i gesti della mano che lavora. Ciascuno visse, per sé, con una grande solitudine dentro l’anima; estraneo, indifferente a quelli che respiravano la stessa aria e tagliavano lo stesso pane, come gente che vive nello stesso albergo senza conoscersi.
Ecco che la sera violacea scende nel vicolo pieno d’ombre, smorzando la luminosità che splende ancora qua e là, sulla sconfinata distesa dei tetti, fino all’orizzonte lontano tutto vermiglio e arancione.
Antonietta è nella propria camera. Essa non comprende quasi più ciò che le dicono: e in casa si sono già rassegnati al nuovo ma tollerabile castigo. Nella luce crepuscolare, dietro la finestra chiusa, essa continua a lavorare, parlando con le immagini sante, nelle quali vede care e buone persone che non l’hanno tradita.
Nicolina è nella propria cameretta, di sopra. A quest’ora non hanno bisogno di lei. Lavora e pensa. Il suo pensiero è amaro, come un nodo di lacrime che non ci riesce di piangere. Siccome la serata è caldissima ha lasciato la finestra aperta: la tonda e piccola finestra, a cui tante volte s’era affacciata con Alessio. Ancora, nella stanza solitaria, sembra risuonare la fresca voce:
«Guarda, zia! La camera, a quest’ora, è la cabina d’una nave che deve lasciare il porto».
La casa tutta, la vecchia nave che marcisce nel porto, piena di viaggiatori che non hanno mai veduto l’ampio orizzonte, è presto avviluppata nell’ombra della notte. Nessuna stanza ha il lume acceso. Don Lucio è fuori. Quando tornerà si vedrà, nella stanza da pranzo, don Lucio seduto davanti la tavola su cui piove la tonda raggera della lampada sospesa che dondola un poco se un passo attraversa la stanza. Egli chiamerà:
— Agata! Di’ a zia Nicolina che mi riempia la pipa.
Le due fanciulle indugiano sul terrazzo, dove un tempo sedeva zia Nicolina. Come andare a letto, quando l’aria è così tepida e non c’è sonno?
Si tengono per mano e non si dicono nulla. Ciò che pensano, e gonfia i loro piccoli cuori, che battono nelle calme sere d’estate come foglioline accarezzate dal vento, è troppo vago e dolce e non sanno esprimerlo. Agata esclama:
— Quante stelle nel cielo! Vogliamo contarle?
E si provano a contarle. E poi tacciono. Giunge un effluvio di fiori. Sarà qualche giardino, non lontano. Un rumore… Forse viene dalla via più larga, di là dal vicolo.
— Non ti pare – dice Agata, – di sentir l’odore del mare?
— Taci! – esclama Carmelina che pensa sempre ad Alessio, quando si nomina il mare. Ascoltano. Un passo, una voce, nel vicolo. Un rigoglio impetuoso fiorisce nei giovani petti. Esse crescono come certi bizzarri delicatissimi fiori che nascono fra le crepe dei vecchi muri e che la pioggia sciuperà presto. Don Lucio tossicchia. Le due fanciulle trasaliscono, ma poi ridono di aver trasalito; e poi tacciono, aspettando di nuovo, trepide e commosse, mentre le ore passano, tacite e gravi, per il cielo stellato.